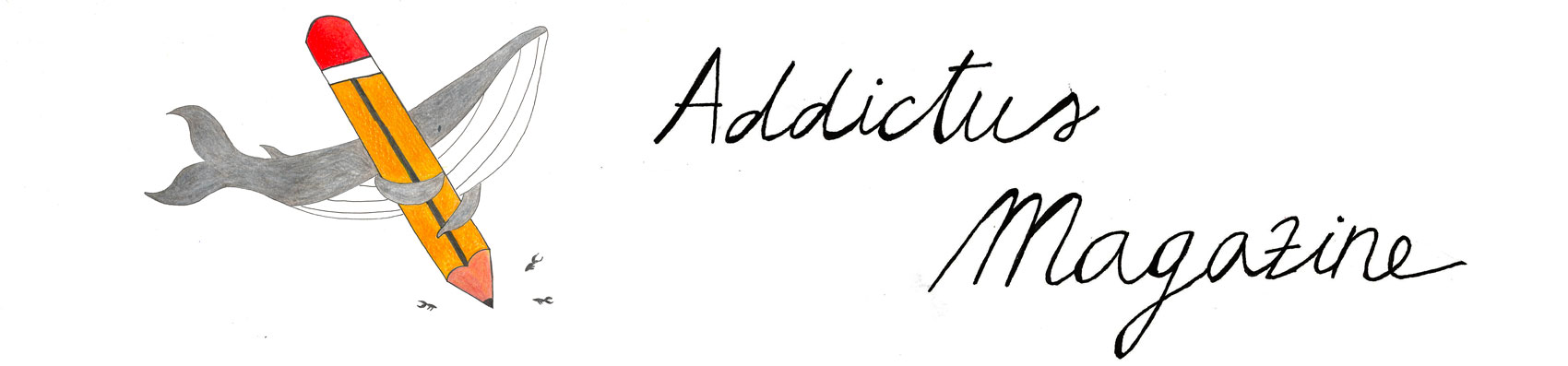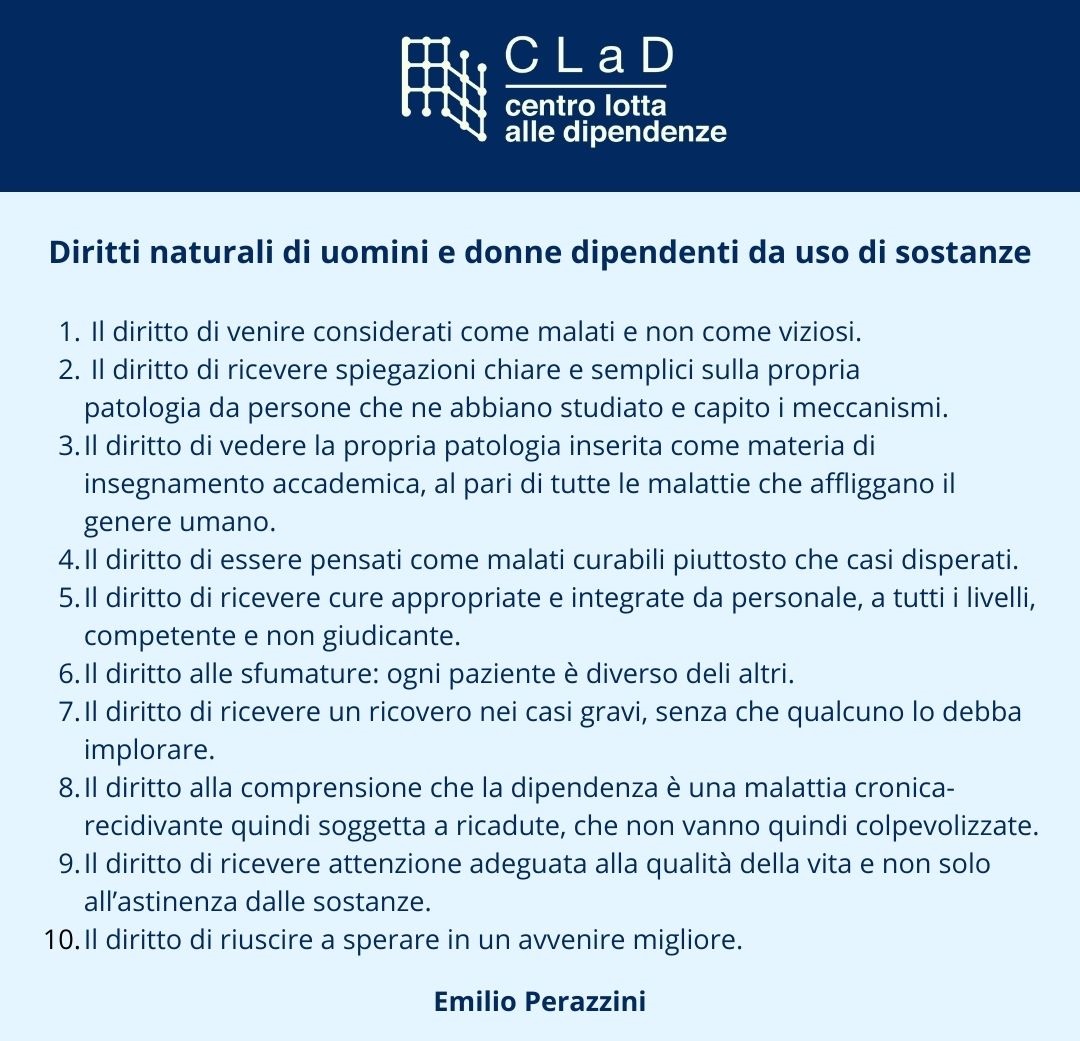Lo sguardo di Maya

Durante tutto il periodo della malattia, il padre lo volle accanto a sé per esorcizzare la paura di fronte all’ignoto del grande salto. Gli schiacciava un po’ i muscoli del braccio e falsando la voce diceva: “Sarai tu il mio bastone. Con questi muscoli mi rimetterò in sesto subito!”. Ma ogni giorno che passava le forze del padre venivano meno e a nulla valeva al piccolo Icio guardarsi i muscoli e fare qualche esercizio allo specchio. Suo padre lo lasciò lo stesso, troppo presto, con i polmoni bruciati dai gas e dagli agenti chimici delle fabbriche assassine, proprio mentre lui si stava aprendo alla vita. La malattia del padre fu terribile e lui dovette continuare a fare il bravo per accompagnare la madre sempre più triste e senza energie. La fatica di essere il collante prima di tutti e tre, poi dei due superstiti, lo sfiancò immensamente, ma soprattutto lo deprivò di quella spensieratezza necessaria per affrontare l’esistenza, per seguire i suoi istinti e le sue vocazioni. La mamma spesso, fra un gratta e vinci e la tombola elettronica del tabaccaio, ripeteva in modo monotono: “Bon, bambin mio!” e questo era tutto il riconoscimento di cui si doveva accontentare e che a volte, in mancanza di altro, si ripeteva fra sé e sé.
Essere figlio unico di una coppia nata già in difficoltà e di un rapporto di mutuo soccorso, non era certo un privilegio. Icio imparò precocemente a fare dapprima il giocoliere, inventandosi acrobazie, giochi, esposizioni a rischi, cadute fortunose e a volte rovinose, poi il bon bambin e in seguito il fuggiasco, l’errabondo solitario. Cominciò ad allontanarsi da casa quando sua madre presa da un raptus, martellò tutte le scale dell’edificio popolare e dovette arrendersi ad un trattamento sanitario obbligatorio. Da allora ebbero inizio i continui ricoveri in cliniche psichiatriche fino a che si perse del tutto. Ricordava di quel periodo la casa chiusa, il silenzio assoluto, le tapparelle abbassate, la puzza di tabacco e di alcool. Se ne andò anche lei un martedì mattina. A nulla valsero nemmeno quella volta i muscoli. Ritornò varie volte nell’appartamento nell’assurda speranza di incontrarla, seppur distesa a letto, con un fazzoletto bagnato sugli occhi e quella voce sbiascicata che lo cercava lì attorno. Avrebbe voluto, almeno per una volta nella vita, un sorriso e un abbraccio oltre al “Bon, bambin mio!”, ma ogni volta incontrava solo gli sguardi ostili e diffidenti dei vicini. L’ultima volta, nel cassetto del comodino nella camera dei suoi, trovò un pacchetto di quei foglietti colorati evidentemente dimenticati prima dell’ultimo ricovero. I gratta e vinci promettevano viaggi in posti paradisiaci, vacanze per sempre, tesori sicuri. Ce n’erano alcuni con dei cani bianchi e neri che gli strizzavano l’occhio e garantivano delle ossa magiche e seli infilò in tasca, carico di speranze.
Di lì a poconon fece più ritorno all’appartamento dei suoi e abbandonò anche il lavoretto di riparazione di biciclette che aveva trovato grazie all’unico fedele amico dei tempi delle medie. Erano poche ore in uno scantinato, ma aveva imparato velocemente a fare la manutenzione e a riparare. Tuttavia non avvertiva alcun interesse per la cosa e dopo qualche mese abbandonò il tutto senza salutare. In realtà non andò troppo lontano, si fermò dalla parte opposta della città, in stazione. Quello gli sembrava il posto ideale. Non sapeva perché, ma era come se potesse partire per qualsiasi direzione in qualsiasi momento e al tempo stesso potesse immergersi nella vita altrui così felice e leggera. Era come se avvertisse dentro di sé una naturale predisposizione per il viaggio, per mettere distanze e non farsene mettere. Preferiva abbandonare invece che esser abbandonato. E poi, aveva ancora in tasca qualcuno dei suoi biglietti magici; cercava soltanto quelli con i cani sicuro che lo avrebbero salvato, gli avrebbero dato quello che da sempre si sarebbe aspettato. Ma ben presto la rincorsa al biglietto magico era diventata un’ossessione, qualcosa di assoluto che gli riempiva totalmente la testa, il premio sarebbe stata la giusta ricompensa per il bon bambin.
In stazione rimaneva seduto dentro una rientranza che dava alla porta chiusa di uffici amministrativi dismessi. Aveva ripulito per bene quel luogo, messo dei cartoni provenienti dal vicino supermercato, stirato un sacco a pelo trovato nella cantina della casa dei suoi, e si limitava a guardare i viaggiatori, i pendolari e soprattutto gli studenti della vicina Università.
Ogni giorno, verso le undici, andava lungo le pensiline a ripulirle dalle bottiglie di plastica, dalle lattine e dalla carta sospinta dal vento, facendosi notare e benvolere da tutti i ferrovieri e dagli addetti ai lavori della stazione. Barattava questo suo darsi da fare con la tolleranza assoluta dentro un anonimato totale e a volte per due soldi che investiva immediatamente. Per i bisogni utilizzava i bagni al primo binario.
Guardava i giovani come lui e provandosi ad immaginare la loro vita, avvertiva in sé una sorta di disagio, un senso di mancanza di qualcosa, come se non potesse mai in realtà abbandonare quel posto perché dentro non aveva una base, un qualcosa da cui partire, solo vuoti, mancanze, quel “Bon, bambin mio!” che esprimeva più un bisogno di rassicurazione da parte di sua madre che un apprezzamento.
All’inizio si vergognava ad usare i pochi soldi che gli rimanevano per comprare pacchetti di fogli colorati; aveva già perso l’appartamento dei suoi genitori, il comune si era anche dato da fare a trovargli un alloggio Ater, ma lui impropriamente lo affittava ad extracomunitari preferendo la trafficata stazione centrale e la certezza che quei gratta e vinci l’avrebbero salvato.
Un giovedì pomeriggio due assistenti sociali arrivarono fino al suo rifugio, sempre comunque ben pulito, e gli chiesero di seguirlo. Lui obbedì docile, senza parlare. Era sorpreso che qualcuno si fosse accorto che esisteva e si fosse avvicinato a lui. Lo condussero a piedi fino al vicino Servizio della Azienda Sanitaria Locale per le dipendenze patologiche, dove avrebbero deciso sul da farsi. Le segnalazioni erano ormai troppe e a malincuore dovettero prendere dei provvedimenti. Per lui, alla mal parata, doveva decidere lo psichiatra di turno o lo psicologo: qualche colloquio, dei tests, una diagnosi, un farmaco, forse una presa in carico presso una Comunità alloggio, una riabilitazione e chissà, forse l’ennesimo reinserimento da qualche parte.
Leggendo la grande targa posta alla destra dell’entrata “SERVIZIO PER LA CURA DELLE DIPENDENZE” sorrise fra sé senza darlo a vedere chiedendosi: “Che strano frequentare questi posti quando non ho mai dipeso da nessuno”. Ma lui era pur sempre il “bon bambin” e aspettò docile e curioso l’evoluzione di tutta quella strana situazione. Sentiva, anche in quel momento, la necessità di grattare via la paura di vivere come faceva sua madre, percependo in quei gesti ripetuti, la ventata di gioia necessaria per affrontare i momenti difficili; tale gesto lo accompagnava a partire fin dalle prime ore dell’alba, ossia da quando il treno delle sei e quarantadue sferragliava a pochi passi dai suoi cartoni distesi e i passanti lo guardavano disgustati schivando i suoi piedi.
Aveva sentito parlare degli psicologi da sua madre come delle persone che aiutano a “mettere a posto la testa”, ma era convinto di non averne bisogno. Stava bene, era lui che aveva deciso volontariamente di abbandonare il mondo. Non doveva rispondere a niente e a nessuno, non esponendosi ad alcuna delusione e non ricevendo nessun rifiuto.
La stanza dello psicologo era l’ultima di un lungo corridoio pieno di porte tutte uguali e bianche. Icio si chiese chi ci lavorasse dietro soglie così anonime e soprattutto quali lavori importanti si potessero mai svolgere. Lui aveva appreso solo a riparare biciclette e a farle funzionare in ogni loro parte, oltre ovviamente a ripulire bene la stazione. Paolo, il suo vecchio compagno di scuola, era molto preciso e gli aveva insegnato a controllare tutti i meccanismi con un’accuratezza maniacale e soprattutto a riconoscere la “voce” della bicicletta. L’unico fruscio ammesso era quello dell’attrito dei copertoni sull’asfalto. Con le ruote sospese nell’aria, la voce della bicicletta era il silenzio.
Prima di entrare riuscì a leggere la piccola targa fuori della porta: Dottor Antonio Lisestri, psicologo – psicoterapeuta. Dipendenze da gioco d’azzardo.
“Buondì Maurizio. Sono Antonio Lisestri lo psicologo che si occupa del disagio giovanile”.
(…)
“Visto che non parli, provo a dire due cose io per te” – aprendo una cartella celeste – “allora qui c’è scritto Maurizio Devise, 35 anni, senza fissa dimora, il padre morto molti anni fa, la madre alcolista morta anch’essa dopo innumerevoli ricoveri in psichiatria. I servizi la conoscevano bene. Da quasi un anno e mezzo vivi in stazione. Ti sei fatto benvolere per la tua disponibilità a pulire la stazione, per il comportamento sempre adattato; un po’ ti arrangi con l’aiuto dei lavoratori. Da qualche mese, però, non ti bastano più i piccoli aiuti che ricevi in cambio dei lavoretti, chiedi soldi e poi li vai subito a giocare al bar della stazione …”
(…)
Il ragazzo stava in silenzio, chiuso nel suo mondo e Antonio sapeva che aveva bisogno di tutta la sua pazienza e delicatezza per entrarci, doveva aspettare che uscisse da quel suo buco da solo.
Il dialogo sembrava finito ancora prima d’iniziare, quando dalla porta finestra che dava al giardino, un husky spinse la porta socchiusa ed entrò.
“Maya, non adesso! Vai fuori! Ti ho detto di rimanere in giardino!”
Il cane si avvicinò al ragazzo annusando l’aria. Icio istintivamente, senza alcun timore, allungò il braccio per accarezzarlo e Maya gli offrì il muso intero fra le mani. Icio allora pronunciò le prime parole del giorno: “E’ tuo?”
“Sì, me lo porto al lavoro e lo lascio in giardino almeno fino a quando fa fresco, perché a casa soffrirebbe di solitudine. Ho predisposto anche una cuccia ed ogni tanto lo faccio entrare in ufficio per farci compagnia reciproca. Ti piacciono i cani?”
“Sì”
“Ne hai avuto qualcuno?”
“Mai”
“I cani hanno bisogno di cure, di un rapporto stretto di dedizione e di una relazione sempre attiva…”
“Lo so…”
“E come lo sai?”
“Ho sempre pensato di essere come uno di loro”
“Cosa vuoi dire?”
“Ho sempre fatto tutto ciò che mi si chiedeva, ma non ho mai ricevuto niente in cambio. C’erano sempre altre cose più importanti. Allora tanto vale non fare proprio niente”
“Hai ragione Maurizio…”
“Icio…”
“Hai ragione Icio. A volte ciò che facciamo non viene apprezzato. Pensa che anche qui al Servizio il mio modo di lavorare non è molto riconosciuto”
“E perché ci lavori?”
“Perché mi piace questa professione e con questa ci vivo…”
“E’ buono questo cane” – rispose il ragazzo cambiando completamente discorso.
“Maya era di un mio paziente. Lui veniva sempre alle sedute con il cane e quando è mancato, fra mettere Maya in un canile e adottarlo, ho scelto di farla vivere con me. Siamo amici intimi, non potevo certo abbandonarla…”
“Di cosa è morto il tuo paziente?”
“Devo essere sincero? Ufficialmente di overdose, ma credo che quando ha capito che fra me e Maya esisteva un buon rapporto di amicizia e che potevo prendermi cura di lei, me l’ha affidato e se n’è andato…”
“Quindi viveva per il suo cane?”
“Evidentemente sì. E tu per cosa vivi?”
“Perché mi sveglio alla mattina con il treno delle sei e quarantadue e poi tiro avanti…”
“E non ti viene voglia di fare niente?”
“Per chi?”
“Per te!”
“Boh, no ho mai fatto niente per me…”
“Potrebbe essere venuto il momento di farlo.”
(…)
“Senti Icio, adesso che sei qui dobbiamo trovare una soluzione. Di solito prendiamo in carica la persona, iniziamo un programma che prevede una serie di incontri di gruppo con un mio collega molto bravo. Potresti venire anche ogni giorno a parlare con me. Troviamo una sistemazione in una comunità alloggio da qualche parte. Non conosco la tua situazione abitativa, se hai diritto all’appartamento dei tuoi oppure hai perso tutto, ma non lavorando non abbiamo molte possibilità che tu possa vivere da solo”
(…)
Il dott. Lisestri uscì dalla stanza lasciando Icio in compagnia del cane. Questi si era addormentato proprio a fianco della sedia e per il giovane, passare la mano sul pelo scuro e bianco di Maya era un’esperienza totalmente nuova. Quel movimento non aveva niente a che fare con quello compulsivo che tracciava segni sui quadrati argentati dei gratta e vinci. Era una sensazione tattile molto forte, un’esperienza indescrivibile oltre il liscio e il morbido; era l’abbandono totale di quell’essere, il suo respiro così profondo, quella fiducia che gli era offerta per la prima volta e che non aveva mai sperimentato prima.
Dopo quasi mezz’ora, la porta si riaprì e comparve lo psicologo assieme a due assistenti sociali del Comune. La più alta e grossa con dei fogli in mano, entrò occupando lo spazio e creando una forte tensione. La sua voce bitonale sgradevole fece alzare Maya che lentamente uscì in giardino preferendo la solitudine a quel fastidioso strepitare: “L’appartamento del Comune è stato riassegnato, in stazione non può andare, dove lo mandiamo questo qui, in albergo? Sono stufa di lavorare in queste condizioni. Ma ti sembra giusto complicare le cose in questo modo? Dovevamo portarlo subito a voi e segnalarlo al giudice tutelare per fargli assegnare un amministratore di sostegno… così avrebbe ancora una casa. Ora è vostro, noi le abbiamo provate tutte… che si arrangiassero loro, ma tu vuoi fare sempre di testa tua. …”
“Va bene, va bene, mi prendo io tutta la responsabilità, non preoccupatevi. Adesso lasciatemi solo con il ragazzo!”
Lo psicologo rimase seduto in silenzio sulla scrivania guardando il muro opposto dove pendeva un pannello pieno di annotazioni e post it. Evidentemente il dottor Lisestri non sapeva proprio cosa fare. Nel frattempo, ripristinato il silenzio e l’armonia, il cane rientrò sedendosi ancora una volta a fianco di Icio. Osservando l’intensità dello sguardo con cui fissava il ragazzo ad Antonio vennero i brividi, era lo stesso che Maya dedicava al suo vecchio padrone. Mentre rifletteva in silenzio, dalla bocca gli uscì una frase stupida: “Ho la bicicletta da riparare”.
(…)
“Toh, con questa chiavetta prenditi un panino e una bottiglietta d’acqua alla macchinetta in corridoio. Intanto aspettami fuori finché non esco. Fra un paio d’ore finisco la mia giornata”.
Il ragazzo uscì docilmente con la chiavetta in mano sedendosi fuori in corridoio seguito da Maya che non lo lasciava un momento solo.
Terminate alcune relazioni e un paio di telefonate, il dottor Lisestri chiuse la porta finestra del giardino, liberò la sua scrivania mettendo tutto nella sua borsa di pelle ed uscì in corridoio. Icio era ancora seduto con la chiavetta in mano senza aver preso niente dalla macchinetta. Continuava ad accarezzare il cane che lo invitava continuamente con la zampa a prolungare quel contatto così gratificante per entrambi. Per un attimo lo psicologo si vergognò di provare gelosia.
“Vieni Icio, usciamo da qui. Tieni tu al guinzaglio Maya” – e s’incamminarono verso il parcheggio dietro al Consultorio – “per il momento andiamo a casa mia poi si vedrà”, consapevole che la decisione avrebbe potuto creargli dei grossi problemi. Non sapeva veramente cosa gli era successo, questa volta però non volle passare dallo psichiatra perché era stanco di etichette vuote. Non considerava Icio un alcolista, un sociopatico, un dipendente o peggio un bordeline; non faceva uso di sostanze e non frequentava compagnie marginali. Era piuttosto un essere fragile e spaventato, un ragazzotto buono e semplice, forse immaturo, a cui era stata tolta ogni possibilità di affidarsi e fidarsi degli altri e a cui non era mai stata data una sola possibilità. Lui, il dottor Lisestri, doveva imparare a fidarsi del suo sentire.
Percorsero la strada di ritorno in silenzio. Maya si faceva coccolare sul sedile posteriore dal ragazzo, mentre Antonio pensava preoccupato a quello che avrebbe dovuto fare e come sistemare il tutto senza problemi. Arrivati a destinazione, scesero in giardino camminando lungo il vialetto, a fianco delle rose colorate e profumate e si fermarono davanti ad una porta in noce con dei finestroni quadrati in vetro doppio.
“Siamo arrivati. Questa porta a piano terra è quella del mio vecchio studio che usavo prima di vincere il concorso all’ASL. C’è un bagno, una doccia, un lettino e tutti i miei libri. Fatti una bella doccia poi selezioneremo tutto quello che hai nello zaino, recuperiamo il recuperabile e buttiamo il resto; ti darò un po’ di roba mia che non uso. Io vivo di sopra. Adesso ti porto un asciugamano” – e accarezzando il cane disse in modo perentorio – “ Adesso tu vieni su con me!”.
Fu molto difficile dormire di notte, sapeva di essersi messo nei guai e di non avere troppe giustificazioni. Osservò l’incartamento dell’ASL, guardò tutte le segnalazioni fatte nel corso del tempo, soppesò la storia familiare e non diede troppe possibilità al ragazzo. Pensò fra sé e sé: “Tempo perso!”
Sorrise guardando Maya sistemarsi per la prima volta alla fine della rampa di scale, quasi a metà strada fra lo studio e l’appartamento, fra Icio e lui. Si chiedeva cosa mai la attirasse così tanto verso quel giovane. Era mai possibile che quel cane e una piccolissima parte di lui avessero ragione a fidarsi? Antonio era sempre un po’ sognatore, forse anche ingenuo, credeva a prescindere nella bontà e nella redenzione dell’essere umano, anche dopo quella volta che in comunità dei tossici gli volevano rivendere la sua di bicicletta, precedentemente rubata. Ancora adesso si rideva alle sue spalle.
Il giorno successivo Antonio si alzò come sempre molto presto per poter fare tutte le cose con calma. S’infilò nel fondo del garage e dal gancio del soffitto tirò giù una specie di bicicletta che chiamarla bicicletta era fin troppo esagerato. Polverosa, bucata, senza sella e con la catena incastrata. Povero papà, se vedesse la sua Rex in quelle condizioni. A fatica appoggiò la bicicletta fuori dalla porta esterna del suo studio, nella vaga speranza che qualcuno comprendesse il messaggio.
Come ogni giorno, Maya s’infilò nell’auto e il dott. Lisestri ripercorse la strada fino al Consultorio aspettandosi chissà quali strali per la decisione, non decisione, presa o non presa, non capiva in realtà niente. Il venerdì lavorava solo mezza giornata e avrebbe cercato di sistemare le cose in ufficio per capire cosa fare con il ragazzo. La sua scelta di lasciarlo da solo era anche una sorta di verifica. Voleva comprendere quanto poteva fidarsi di Icio e delle sue proprie sensazioni.
Tornò a casa dopo essere passato dal supermercato a prendere un pollo arrosto per mangiarlo insieme a Icio. In frigorifero si trovavano anche dei contenitori con del riso e della pasta avanzate dai giorni prima.
Entrando in giardino comprese immediatamente che in casa non c’era nessuno; Maya cercò la presenza del ragazzo in studio, inutilmente. Il dottor Lisestri si era sbagliato, aveva dato fiducia a uno sbandato che viveva per strada, a un immaturo poco raccomandabile, si era lasciato ingannare giocandosi la già poca credibilità presso l’Azienda. Sarebbero seguiti giorni difficili. Si chiuse in casa molto arrabbiato con sé, frustrato e al tempo stesso preoccupato. Non sapeva veramente cosa fare, se avvisare d’urgenza i Servizi ed iniziare la caccia al fuggiasco e farsi ridere dietro fino alla pensione, oppure sbollire la rabbia in solitudine e pensarci l’indomani sapendo che Icio non sarebbe mai stato in pericolo di vita. Arrivò persino a provare pena per se stesso. Passò tutto il pomeriggio
A metà giugno le serate erano molto lunghe e quando imbruniva a volte sul piccolo giardino danzavano i brillii timidi delle lucciole in amore. Maya abbaiava confuso. Una di queste luci aveva però un bagliore troppo intenso e correva dritta verso il cancello e solo un orecchio attento e scrupoloso poteva avvertire il fruscio delle ruote sull’asfalto; il resto aveva la voce del perfetto silenzio di una Rex messa finalmente a nuovo accompagnata da un grande sorriso felice.
FINE
Scritto da Nevio Del Longo