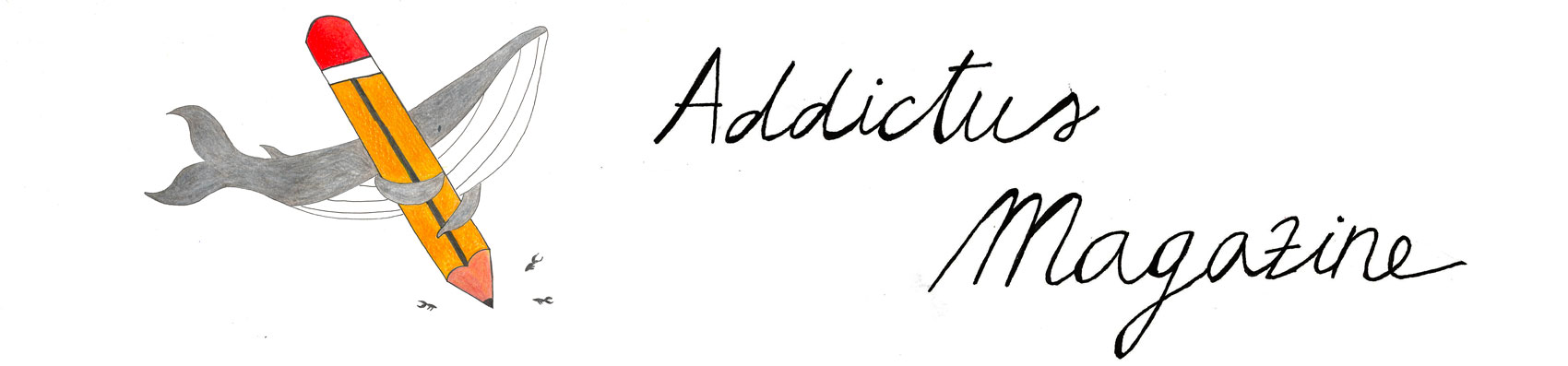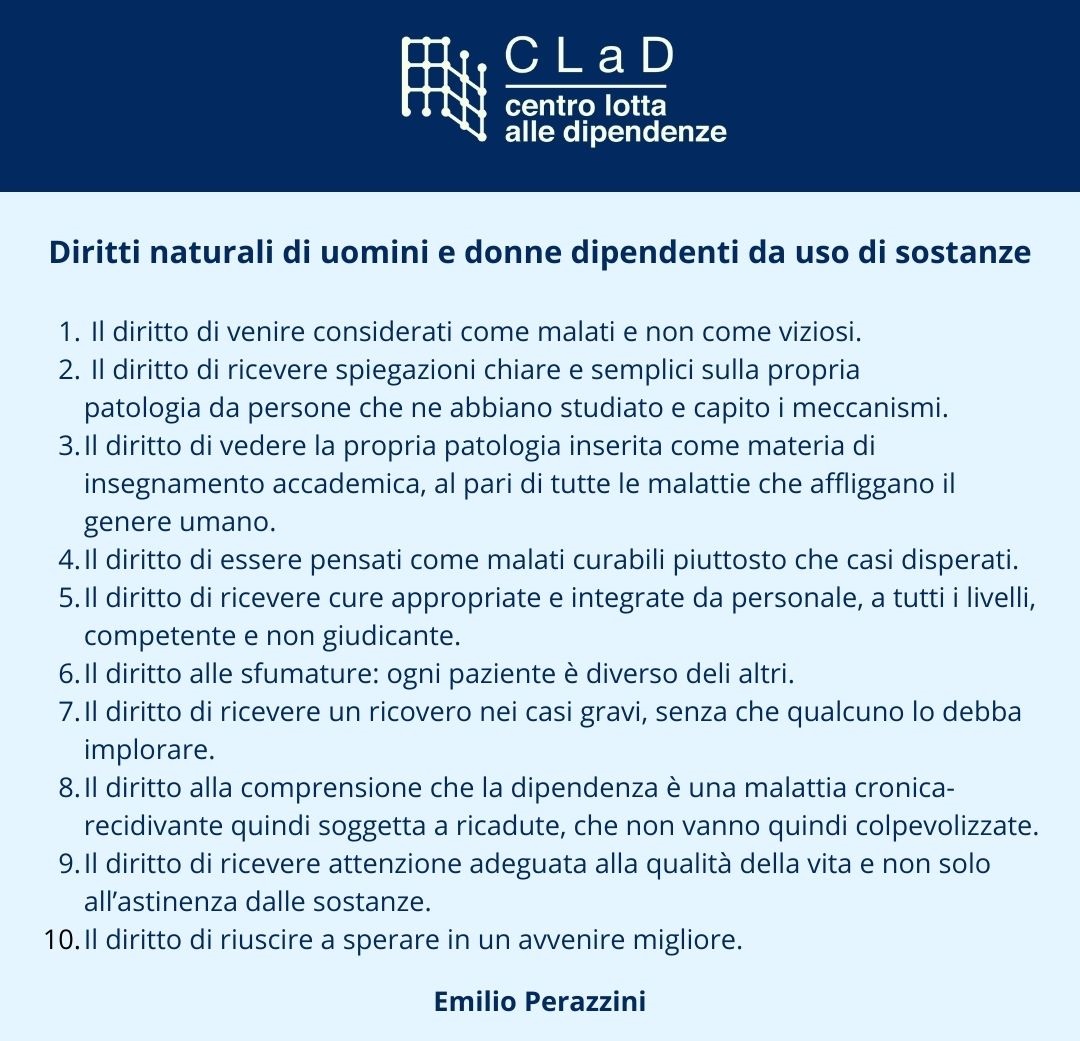Le nozze chimiche

Sono le tre. Notte di umori rancidi. Pori slabbrati. Secrezioni lattiginose di malata adipe. Scolio di giallastri rigagnoli: primo stadio della malattia.
Sono le tre, e delle tre è il tremore. Freddo è per brividi, caldo è per spasmi, leggi: contorsione/contrazione/circonflessione. Il pendolo cellulare rimbalza tra nadir e zenit.
Sono le tre e non uno straccio di gancio verrà a redimermi dal morbo.
Cellule scarsamente (cellule trafitte di spilli, cellule come celle dalla quale il dolore, proprio e nemmeno volendolo, riesce a uscire) convinte tentano di ribellarsi, ma a quale pro: oramai assuefatte al gioco, addomesticate al giogo del breve mandato dell’estasi esogena.
Cellule rifiutano di comporsi/coincidere/collimare: il mosaico somatico (fratturato) è una sfatta, grigiastra maschera agitata a tempo di brividi e spasmi. Una maschera che non è me.
Sono le tre. Tre per: tremore/contorsione/contrazione/circonflessione.
Il morbo: momento migliore per non trovarmi allo specchio (tratti di vampirismo registrati tra gli effetti collaterali), impossibile far coincidere sembiante ed essenza, spirito e avatar.
Me stesso: condizione di tempo-luogo intesa nel senso sensibile della realtà.
Me stesso: dimensione planare il cui portale è custodito dal più esigente sigillo, disfatto golem di creta oppiacea che esiste solo tra un riflesso di luna e l’altro, una scaglia di tempo giallopastosa che brucia in secondi per donarmi un’esistenza (giorni un tempo, poi ore e ora quel poco che è quasi un niente) in minuti. Un tempo strettamente organico, famiglio della materia vile: orologio assestato sui meridiani di Delta e di Mu. Rimbalzo (io, il pendolo) tra nadir e zenit e nello specchio c’è scolio di rigagnoli di pori slabbrati di secrezioni e suppurazione. C’è una sfatta grigiastra maschera agitata a tempo di brividi e spasmi, una maschera che non è me, no/per niente/affatto.
Sono le tre e quarantacinque, non uno straccio di gancio verrà a redimermi dal morbo.
No. Occorre eclissi, subitanea e perfetta. Oscurare l’alba dell’astinenza per tornare a giacere in quella accogliente/comoda/tiepida bara confezionata a misura d’analgesia. Racimolare i miseri granelli di sabbia rimasti nella clessidra per vomitarmi in strada in cerca dell’ostia santa (in te la medicina che dà sollievo alla nostra debolezza). Occorre una sposa da condurre all’altare per queste nozze chimiche.
Sono le tre e cinquantuno e questa squallida stanza soffoca nella gialliccia tenebra dell’abat-jour, devo fuggire da qui. Ho in qualche modo imposto alla carne di entrare dentro i vestiti, sudando e tremando a un tempo ho indossato due paia di pantaloni, due paia di calze, una maglietta e due felpe pesanti sotto al giaccone. In un corale di fitte e pulsanti frattaglie mi sono chinato ad allacciare gli stivali. Ho raccattato i soldi dal tavolo le chiavi e il telefono per barcollare lungo le scale e fino al portone. L’ho aperto con una mano che non credo fosse la mia.
Sono le tre e cinquantadue e non c’è pelle. Non c’è pelle che possa proteggermi da questo freddo, non c’è pelle che mi appartenga, né sangue di cui io disponga se tu non voglia. L’aria gelida mi dà il benvenuto in strada con un calcio al ventre che mi spreme le viscere. Vorrei fuggire (ancora e al contrario) e tornare a chiudermi in casa, a patire nel letto, mantecare nel sudore (giallo) delle mie febbri, ma equivarrebbe a consegnarmi a una sentenza (feroce e protratta astinenza finché il condannato morte non colga) già scritta. Cercare invece, fiutare. Nella notte scura il vento abbaglia la carne e ogni ombra è promessa, speranza presunta, una speranza che vorrei (che vorremmo) realtà. Trascinando stanche spoglie a fatica, attraverso la via, pesanti, il giubbotto sobbalza a ogni passo facendo salire spifferi (come dita di medico intente a palpare una cavia da vivisezione) lungo la schiena, le ginocchia trafitte di crampi. Qual malcomposto ingranaggio, malassemblato impianto, malconnesso sistema: un cigolio ogni respiro, uno stridore ogni passo. Il sudore mi imperla la fronte e il senso di vomito accompagna ogni sorso d’aria. Mi muovo da una pozza (gialla) di lampione a un’altra, curvo sotto gli strati di vesti, lanciando rapide sbirciate a quella (tratti di vampirismo, effetti collaterali) sagoma che appare e scompare nei vetri delle macchine lungo il marciapiede, colando incertezza a ogni macchia d’ombra, dicendomi che no, non troverò nessuno, che è tutto inutile. Eppur devo: ingoiando (ogni sorso d’aria) bicchieri di bile proseguo verso la piazza, in fondo alla via, distante eoni-miglia. È il punto nevralgico, lo snodo, è l’oasi. L’agorà dove torno e ritorno costantemente ad ascoltare un sapere che già conosco a memoria.
Sono le tre e cinquantaquattro ed è disagio dentro e intorno a perdita d’occhio, scorro lungo il marciapiede costeggiando i muri come un gatto malato, la testa invasa di pensieri altrui: ce l’ho dipinto in faccia (lo vedono, sicuramente) che sono in scoppia sparata. Manca poco alle quattro, è la passerella della migliore fauna notturna. Là un barbone accasciato e semincosciente, lo supero in una nuvola di vino scadente e puzzo di cessi pubblici. Là due arabi fermi fuori da un minimarket, bevono birre e uno dei due mentre parla gesticola concitato, mi rivolgono occhiate ostili. Là un uomo anziano, la bicicletta appoggiata a un palo, rovista nei cassonetti e, poco distante, una donna seduta su un gradino, semivestita e nonostante questo incurante del freddo (guardandola i brividi crescono lungo l’interno coscia, attraversano il ventre, salgono lungo l’addome e la schiena e producono un tremulo schiocco quando scoppiano dietro la nuca), è seduta su un gradino. Attorno agli stivali una pila di gratta e vinci giocati, una manciata di mozziconi di sigaretta alla quale si aggiunge quella accesa che getta distratta proprio mentre le passo accanto, un nuovo biglietto già pronto da grattare appoggiato al telefono tenuto in equilibrio sulle ginocchia. Mi rivolge parole (gialle) rauche che non capisco, che non mi interessano, credo mi rivolga uno sguardo ostile ma sono troppo agitato per girarmi a guardarla. Devo arrancare ancora pochi (bicchieri di bile/eoni-miglia) passi e sono in fondo alla via.
Sono le tre e cinquantotto. La piazza mi si schiude davanti come un aborto d’ostrica: è una ghiandola inaridita, la discarica a cielo aperto delle speranze difettose e scartate, è il desertico alveolo di un cuore privo di polpa. Vuota. Luci di (ciclopiche teste di totem) semafori per redarguirmi dall’alto (penzolano, mozzate) come severi occhi al neon, immondizie a danzare incorporee nell’aria, spettri di un Natale presente che non si celebrerà questa notte. Acido (giallo) freddo scroscia attraverso il cranio e lungo la fronte e mi sento come se dovessi accasciarmi, come se la faccia mi si staccasse e potessi toglierla come una maschera e appallottolarla e gettarla a terra, come se la faccia mi si staccasse e potessi scartarmela come un pacco regalo (Natale presente che non si celebrerà questa notte) con dentro il niente, come se la faccia mi si staccasse e non uno straccio di gancio verrà a redimermi dal morbo. All’angolo dove di solito vengo a fornirmi trovo solo cartacce e bottiglie vuote e scritte sui muri: la salvezza non è più qui.
Sono le tre e cinquantanove e mi guardo intorno sperando nell’apparizione di un messia dell’ultima ora, un redentore per carni già in odore di putrefazione. Ma le mie carni attirano altro, ecco: lì dal controviale emerge il vascello biancoblu di una volante, mi fiutano/mi vogliono/sono una preda/già li vedo dietro il parabrezza/sicuramente mi stanno scrutando con occhi ostili/meglio allontanarsi da qui.
Di nuovo le strade dove nella notte scura (di nuovo) ogni ombra è promessa, è speranza presunta, è dubbio, è menzogna. No, è una promessa: attraverso la vetrina del bar cinese (aperto 24/7) e in mezzo ad attempati e tardivi giocatori di macchinette scorgo il Barbuto, chino al bancone fissa con occhi vitrei una tazzina di caffè che non gli interessa. Nervoso, sudante, sudato: sicuramente attende un gancio. Bisogna tentare. Sono le quattro in punto quando faccio il mio ingresso per avvicinarmi con disinvoltura al banco, sbavando saliva guasta di scoppia, ammiccando intorno gioviali sorrisi da palpebre (gialle) viola di insonnia e di reumi. Ordino una birra e con un movimento di scricchiolii sinistri del capo mi volto a fissare il mio forse salvatore.
– Buona sera, – Inizia il corteggiamento. Odio questo galateo di tossici, ma sono le regole, sono le quattro e un minuto.
– Ehi… anche tu qui, eh? – sogghigna lubrico, che già ha capito cosa sto cercando, non che potessero esserci dubbi. Sono le quattro, un minuto e dodici secondi, gocce di sudore pastoso mi affiorano all’attaccatura dei capelli e alle tempie.
– E già… sbirri in giro, pessima serata… – rispondo mentre mi giro a guardare distrattamente il bancone: la birra è lì, materializzata poco distante dal mio braccio, la bottiglia imperlata di lacrime di condensa, come la mia fronte. Sono le quattro, un minuto e ventotto secondi e gocce di sudore pastoso affiorano e scivolano dalle sopracciglia, dalle palpebre, mi inumidiscono la superficie del naso.
– Lo so, è pieno. Si sono presi anche Jackson, la piazza è scoperta. – Mi scruta con occhi di taglieggiatore. Sollevo la birra ed è sciroppo denso e dolciastro nella mia bocca, il freddo frizzante ferisce la lingua e trattengo a stento un conato, il gelo si diffonde sin sotto la pianta dei piedi. Sono le quattro, un minuto e trentatré secondi e gocce di sudore pastoso mi formano piccole pozze sotto agli zigomi e nell’incavo delle guance e il barbuto prosegue.
– Comunque, sei fortunato. Ho sentito un gancio che c’è pure a quest’ora e dovrebbe arrivare a servirmi tra poco, solo che costa un po’. – Bastardo. Ma tanto non c’è altro da fare. Ma tanto a questo punto tutto va bene. Almeno non ci ha girato intorno per ore. Sono le quattro e due minuti e gocce di sudore pastoso mi scivolano lungo la curva della mascella, si raccolgono in punta al mento. Gli mostro i soldi, lui annuisce. Mi indica la porta del locale, usciamo.
Sono le quattro e due minuti e cinquantanove secondi. Si crepa di freddo e il vicolo in cui aspettiamo puzza di merda. Il gancio dovrebbe star arrivando, ha detto che era per strada, che due minuti e sarebbe arrivato e
Sono le quattro e quattro minuti e quarantacinque secondi. Le mie pupille probabilmente sembrano dischi volanti (-Richiamalo. Diglielo che siamo qua. -) ho la lingua secca per l’ansia (- Squilla… no, l’ha buttata giù, sto’ pezzo di stronzo. -) sudore pastoso mi impregna il collo e mi bagna le scapole.
Sono le quattro e cinque minuti e sei secondi. Le mascelle sono come gomma (- Spe, che richiamo… -) i polsi e le ginocchia indolenzite come le avessero pestate col batticarne (- Hey! Caro…) il cuore bussa aritmici colpi di tachicardia e (…si, siamo qui, siamo in quattro come ti ho detto…) la schiena è fradicia di sudore pastoso (…al solito angolo…) che cola lungo il fondoschiena fino a bagnarmi il culo.
Sono le quattro e cinque minuti e diciannove secondi. Sento i capelli appiccicati sulla fronte come estranee antenne di (…e quanto ci metti…?) insetti gialli e li posso percepire a uno a uno (…ok, aspettiamo, ma non metterci tanto…) ho i piedi ghiacciati, sento solo i piedi e le mani e il resto è una pozza gialla (…dai, noi siamo qua… un minuto… ok caro…) di vuoto sospeso, aleggia come un fantasma giallo tra la testa e le terminazioni degli arti.
Sono le quattro e cinque minuti e ventisette secondi e il gancio non arriva.
Sono le quattro e cinque minuti e trentasette secondi e il gancio non arriva.
Sono le quattro e cinque minuti e quarantasette secondi e il gancio non arriva.
Sono le quattro e cinque minuti e cinquantasette secondi e il gancio non arriva.
Sono le quattro e cinque minuti e cinquantotto secondi e il gancio non arriva.
Sono le quattro e cinque minuti e cinquantanove secondi e il gancio non arriva.
Sono le quattro e sei minuti e
Lo vedi.
Appare come miraggio, il volto un chiaroscuro di ombre incorniciato in cappuccio nero, ammantato in felpa e cappotto lungo e scarpe da ginnastica alte è l’agnello di Morfeo venuto a redimere i peccati del corpo (dona a noi la pace), si avvicina a passo svelto facendo cenni con la mano per farci preparare i soldi e noi, mendicanti di sinagoga, pellegrini estatici nell’immagine del santo sepolcro, ubbidienti usciamo il contante (dona a noi la pace), lui sorride un sorriso magnanimo di pontefice e caccia di bocca una manciata di buste, variopinti pallini in plastica che sgrana tra le dita come grani di rosario (dona a noi la pace), tendiamo le mani a ricever (l’ostia santa) tanta grazia, subitanea grazia senza mezzi termini, un colpo di mazza (in te la medicina che da sollievo alla nostra debolezza) che blandisca il dolore e stordisca le membra, vitelli bramosi di mattatoio.
Sono le quattroequalcosaechisenefrega.
Ovunque ti trovi è un qualunque posto che per questo va bene.
In culo ai pochi passanti agli sguardi alle occhiate ostili in culo alla gente che sente e apri sto portone apri una shell di stagnola con mani tremanti (attento!) non farla cadere che è pure poca però ha detto vaccipianoèbuonaattenzionechesballa e infatti la carico tutta il pezzo vuoto giallo embrione involucro feto svuotato succhiarne la linfa (veloce, veloce!) mi affaccio sul foglio di alluminio mi affaccio nell’unico specchio (tratti di vampirismo, effetti collaterali) in cui ancora riesco a vedermi me stesso.
System Reboot:
Strisce nere (dopo molte ferite inferte all’umanità) per mostrarmi il tracciato (qui, per consiglio di Dio) code di stella cometa per mostrare (e per l’aiuto dell’arte) al viaggiatore la via del ritorno in questo decrepito veliero di carne (scorre una medicina curante) malata/macilenta/disfatta che ancora ritrova vigore nelle (beva da me chi può bere, si lavi in me chi vuole) volute spirali bluastre chimiche della spezia oppiacea: castigo-cura/siero-veleno/maledizione-dono (sia turbato chi osa), inscindibile diamante di dolente dualismo. Strisce nere scivolano (bevete, fratelli, e vivete.) e vedo attraverso: alluminiomante già leggo il prossimo domani della disfatta, l’assedio, il tempo è contato ma no, non adesso, adesso è trionfo e il trionfo è urlo, ululato dell’estasi esogena, della vittoria della manna oppiacea sulle miserie della mente-corpo afflitta. Morfeo da lassù ci tutela, ha inviato una sposa, un’ancella, una figlia a tender la mano per accompagnarmi all’altare delle nozze chimiche.
E. Non. C’è.
Tempo. Mentre.
La Roba. Frigge.
Una notte di eclissi subitanea e perfetta (il tempo è un cristallo) una notte di fulgida notte il buio risplende (sospeso, immobile) nella festa di cellule (ancora per), recettori ancora una volta redenti (pochi secondi).
Umori rancidi (d’eternità) dissipati, pori sanati (ancora per), taumaturgica reversione (poco.) della malattia.
Sono le cinque. Notte di umori rancidi. Pori slabbrati. Secrezioni lattiginose di malata adipe: scolio di giallastri rigagnoli.
Primo stadio della malattia.
Scritto da Ivan Marcia