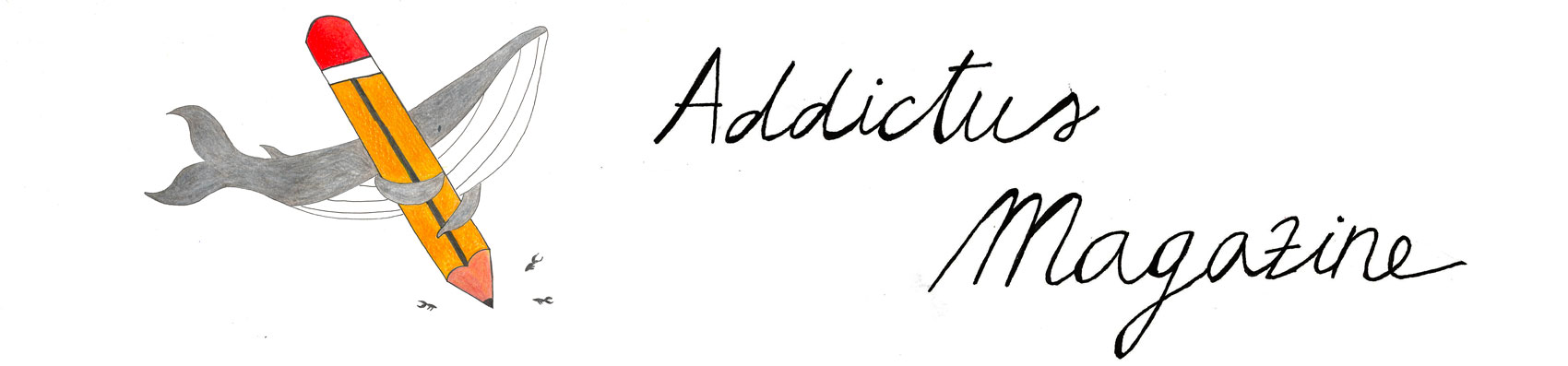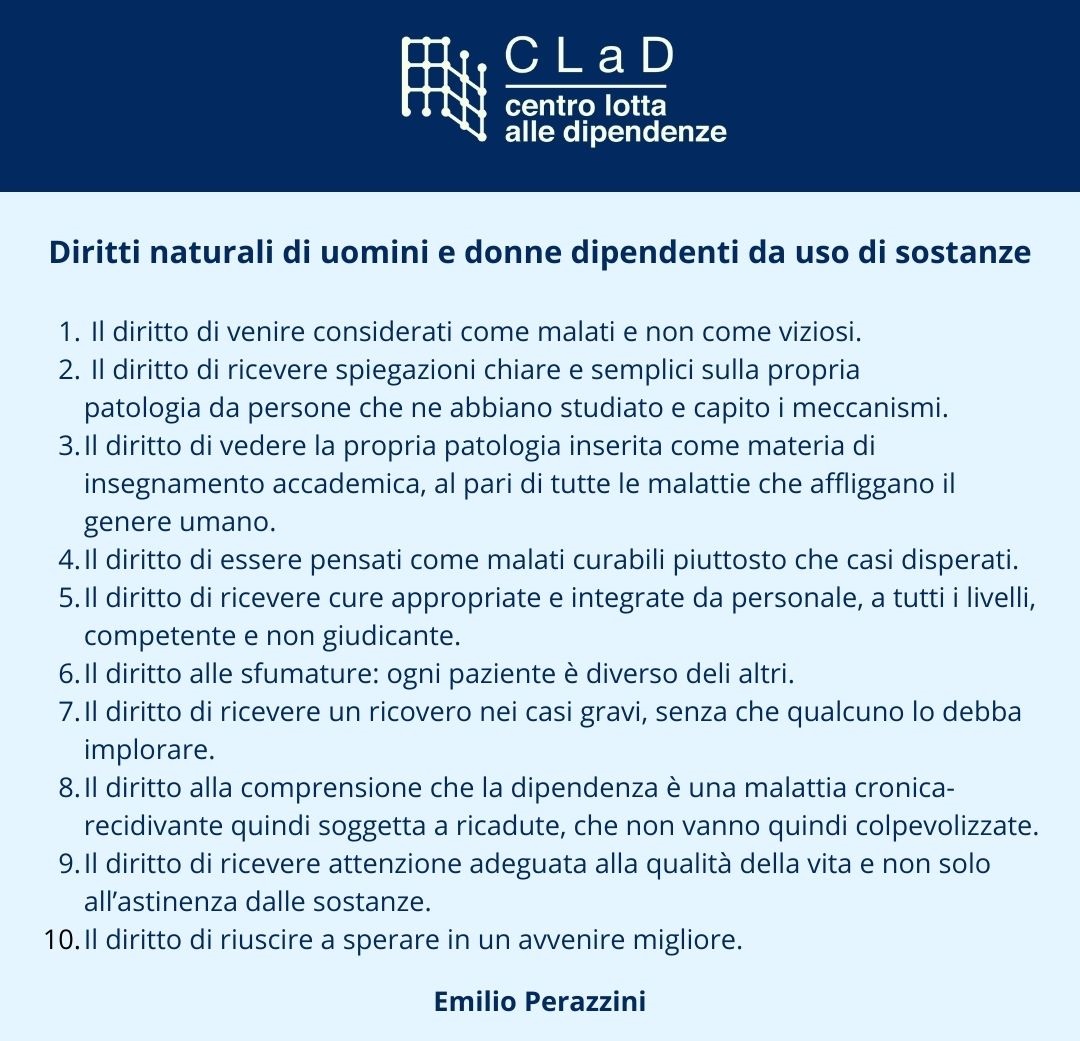Un padre

“Chi? Rodolfo?
Ma certo che lo ricordo. Non sapevo fosse lì.
Vorrebbe vedermi? Va bene, vengo con piacere.
Ma cos’è successo?
Ah, suo figlio? Oh mamma mia! Quando lo avevo in carico era in carrozzina… “
La telefonata è giunta inattesa, da un anziano collega che non vedevo da anni, e che ora, a quanto pare, fa il direttore sanitario in una casa di riposo.
Rodolfo è stato un vecchio utente che avevo seguito al Ser.D, che allora si chiamava ancora Ser.T, per un sacco di tempo; uno di quelli per così dire storici, col quale avevo convissuto da medico a “paziente” per anni e anni, accompagnandolo attraverso innumerevoli traversie.
Lui era già utente del servizio quando io ero entrato a lavorarvi. Uno di quelli tosti.
Apparteneva a uno dei gruppi che per primi in città si erano dati all’eroina.
C’erano i contestatori sociali, gli anti-borghesi, e accanto a loro bivaccavano gli emarginati.
Rodolfo non apparteneva propriamente a nessuna di queste categorie, piuttosto a quelli che avevano creduto di poter sfruttare la situazione dei più deboli a proprio vantaggio, inserendosi nel mondo che affiancava lavoretti mal pagati a minuta delinquenza. Si era dato quindi al mercato del piccolo spaccio; ma poi, essendo anche lui fondamentalmente un disadattato (come si diceva allora), pur credendosi uno sfruttatore del sistema, era cascato mani e piedi legati dentro al “tunnel”.
Non se ne dava pace però; ed essendo dotato di una personalità tutto sommato non comune, aveva continuato a dibattersi furiosamente dentro i lacci della dipendenza, ricorrendo a tutti gli espedienti possibili per non farsi troppo trascinare dalla corrente negativa, senza avere tuttavia mai lo scatto e il coraggio, o la forza, di uscire completamente da quelle sabbie mobili. Il tutto unito a uno sprezzo per quasi tutti i suoi compagni di avventure, speculare a quello che provava per chi invece viveva in una apparente tranquilla normalità borghese.
Era un tipo duro, Rodolfo: o meglio, giocava -prima di tutto con se stesso- a fare il duro. Ti metteva continuamente alla prova, soppesando le reazioni a quel suo fare sarcastico e supponente, tanto più sostenuto quanto più sentiva di doversi umiliare a chiedere aiuto.
Miracolosamente, forse perché da sempre tipi del genere mi incuriosivano sul piano umano prima ancora che su quello professionale, e conseguentemente non cadevo nelle loro trappole provocatorie, ma nemmeno mi sottraevo al confronto, anzi, ero curioso del loro modo di vedere il mondo, stabilimmo da subito con Rodolfo un canale franco di comunicazione: io ero lì per cercare di aiutarlo a non farsi troppo male, senza pretendere di cambiarlo; e lui -constatata con grande circospezione la mia posizione di assoluta astensione dal giudizio- poco a poco cominciò a utilizzare le visite al Ser.T, quando trovava me, non solo per le terapie mediche, ma anche per confrontarsi intorno alla società in cui ci trovavamo a vivere, su sponde quasi opposte, sugli infidi compagni di strada, sulle magagne della città e tutti i suoi migragnosi piccoli traffici palesi che ne nascondevano altri ben più importanti e spesso vergognosi.
Non erano sempre divertenti, ricordavo, quelle conversazioni. Rodolfo a volte ci andava giù pesante -lui- nei suoi giudizi, che non risparmiavano me e i miei colleghi, il ruolo fragile del nostro lavoro, le stesse terapie (“se devo infognarmi, lo faccio con la roba, non con il metadone!”), mettendo in risalto le ipocrisie che lui vedeva nel nostro ruolo, quasi cani da guardia dell’ordine sociale, disprezzati e messi all’angolo dagli stessi poteri che ci avevano mandato lì in trincea, con pochi mezzi e ancor meno prestigio.
Eppure interessanti, quei confronti senza peli sulla lingua, dove intuivi che tutto il rancore distillato nelle parole rivolte contro l’esterno era in gran parte solo una proiezione del giudizio negativo che il ragazzo dava su se stesso, e rispetto al quale l’eroina costituiva un potente ma ambivalente e pericoloso anestetico.
I pericoli da eroina Rodolfo li aveva corsi tutti, oltre alla dipendenza: overdose, da cui una volta fu miracolosamente salvato tramite una tempestiva rianimazione praticata da una pattuglia della Polizia su una panchina del parco, infezioni epatiche, e infine, va da sé, l’HIV!
Quella, fu la svolta. Perché, dovendosi curare l’infezione mortale, accettò di abbassare le ali, ed entrare in una Comunità dove interrompere la sua vita centrata essenzialmente sulla strada, e cercare di riprenderne le redini, pur se ciò gli doveva costare una sostanziale abdicazione ai suoi tanto sbandierati principi di contestazione della società conformista.
Nel frattempo, però, prima dell’ultima ricaduta che gli avrebbe regalato l’HIV, a quella stessa società aveva dato un figlio, avuto da una compagna di strada che era rimasta ammaliata dalla sua personalità eccentrica e malandrina. Ammaliata e illusa, come spesso accade, di avere forza e potere di “salvare” il suo amore dalla vita che andava conducendo, o almeno da quella parte che implicava l’uso di droga.
Strano a dirsi, lei era rimasta immune dai pericoli dell’uso; si era affiancata lungo un certo periodo a quello che era diventato il padre di suo figlio inducendo Rodolfo, per amore della ragazza, ad accarezzare un momento la prospettiva di uscire dalla palude della sua esistenza sempre al limite, cercando un lavoro meno occasionale, e abbandonando per un po’ il milieu bohèmien in cui aveva sguazzato fino ad allora. Si era accasato come un qualunque piccolo cittadino, di quelli che fino ad allora aveva sempre guardato con ironico disprezzo.
Mi ricordo del giorno in cui se ne era arrivato in visita di cortesia al servizio con compagna e carrozzina: a quel tempo non seguiva più alcun trattamento, nonostante gli avessimo tutti consigliato di non abbandonare almeno le terapie mediche. Figurarsi, lui faceva tutto da solo!
Ed eccolo qui, nelle vesti di padre emozionato e compagno amorevole…
Emozionato lo era per davvero, ma si percepiva alla prima occhiata quanto fosse totalmente fuori ruolo. Si sforzava, visibilmente, di apparire premuroso e felice: troppo teatrale, troppa esibizione di affetto per il pupo, troppi abbracci e baci alla compagna, la sua “salvatrice”.
Non era tipo da farsi salvare, Rodolfo. E infatti non si salvò.
Pochi mesi dopo, eccolo di nuovo qua, stavolta nei panni ben più consolidati di una crisi di astinenza disperata, solo e ramingo come prima, trascinato quasi al servizio dai vecchi “amici”, che lo avevano riaccolto nelle proprie congreghe, in fuga da una pace domestica apparente che in realtà aveva sentito stringersi al collo come una garrota col trascorrere del tempo.
La compagna lo aveva cacciato di casa, dopo la scoperta dell’ennesima siringa sporca di sangue, maldestramente, o forse inconsciamente, lasciata in giro. Anzi, per essere proprio sicura di rescindere tutti i legami che aveva avuto con lui, soprattutto riguardo al bambino, se n’era andata insieme all’infante a stare lontano, in un’altra città, una metropoli fuori dalla portata di un possibile ritorno di fiamma, da parte di lui come di se stessa.
“E tuo figlio, maledetta me che l’ho messo al mondo con un disgraziato come te, tuo figlio non lo vedrai mai più!”
Disperazione totale, dunque, autodistruzione.
Ma Rodolfo non sarebbe stato Rodolfo se si fosse davvero lasciato travolgere da quella scivolata senza fine. Teneva troppo a se stesso, in fondo, per non proiettare sulla compagna almeno parte delle responsabilità di ciò che era successo. Cosa in fondo anche vera, se si pensa a come era fatto lui: non aveva mai inteso ingannare nessuno, solo per una volta aveva voluto credere alle illusioni che si era fatta la ragazza, indossando per qualche tempo i panni che lei gli aveva cucito addosso. Ma non erano i suoi, quei panni, c’era poco da fare.
Quindi, dopo vari pianti e strepiti, aveva accettato i nuovi trattamenti, e si era piano piano rimesso in piedi.
Ma la sorte non gli era stata benevola: al controllo di routine degli esami infettivologici, ecco la sorpresa: HIV positivo!
Erano gli anni, quelli, in cui la sieropositività per l’HIV suonava come una sentenza di morte. Morte differita, si capisce, ma inevitabile, nonostante le rassicurazioni di tutti noi che ci prodigavamo a mettere sotto la miglior luce possibile farmacoterapie efficaci, per quanto complicate, nuovi trattamenti sicuramente all’orizzonte, affiancando moniti insistenti a cercare di preservare quanto di sano l’organismo manteneva, e dunque a non usurarne ulteriormente la fibra attraverso il persistere nell’uso di sostanze e nella vita di strada.
Rodolfo aveva fatto dapprincipio il rodomonte, vedendo nell’infezione una sottolineatura del proprio ruolo di eroe maledetto; dall’altro lato però, nei momenti di depressione, o di voluto pietismo, interpretava la parte del “me lo sono meritato, con tutto quello che ho combinato”; che a ben guardare erano solo due facce della medesima medaglia, un narcisismo a prova di bomba.
Poi era finito in ospedale per uno pneumotorace, che ne aveva minato pesantemente fisico e morale.
Rodomonte era sceso improvvisamente dal piedistallo, e il piccolo Rodolfo aveva deciso di venire a patti con la sorte, accettando la soluzione di un ingresso in Comunità dove riprendersi dalle ferite che le battaglie condotte col mondo, fino ad allora in fondo tutte perdute -lo riconosceva, non difettava certo di intelligenza-, gli avevano inferto, fin quasi ad annientarlo. Non era eroe da sfidare il destino fino al duello mortale, se non a parole. E quindi, approfittando del ricovero forzato per una disintossicazione fuori programma, all’uscita dall’ospedale facemmo in modo che fosse trasferito senza pericolose soluzioni di continuità, che lo avrebbero esposto a rischi mortali di overdose in caso di nuove assunzioni di eroina, dato lo stato fisico acquisito di drug free in cui era stato dimesso, in una struttura residenziale attrezzata anche per la cura dell’AIDS.
La vita che aveva condotto fra la scoperta della sieropositività e l’episodio dello pneumotorace, col rifiuto iniziale delle terapie antivirali, aveva fatto galoppare il deterioramento dello stato immunitario, ciò che necessitava quindi non solo di un cambio di vita urgente e totale, ma anche di una stadiazione attenta dell’infezione con la conseguente definizione di un’adeguata strategia terapeutica.
Ricordo ancora il giorno in cui lo accompagnammo in Comunità: fosse che era snebbiato dopo la cura di disintossicazione, fosse che sentiva di avere bisogno di noi e del luogo che avevamo scelto per lui, e quindi sentisse da parte nostra la sincera preoccupazione per le sue condizioni e la sua stessa vita, ci rivolse un riconoscente e franco sorriso, stingendoci forte la mano con le lacrime agli occhi, mentre raccoglieva la sacca e varcava la soglia della sua nuova dimora. Si girò ancora indietro, prima di entrare nella casa, e ci salutò col braccio levato, sventolando l’immancabile cappellino a visiera che si era tolto di capo per un momento.
Non lo vedemmo più al servizio.
Lo seguimmo però nelle sue varie peripezie di trattamenti sia per l’infezione da HIV, e le altre patologie contratte durante la carriera tossicomanica, sia per quella dipendenza dalle droghe, e dall’eroina in particolare, che aveva impregnato a lungo il suo cervello.
Non fu un percorso lineare il suo, come quasi mai lo sono questo tipo di traiettorie. Ebbe momenti di crisi, di fuga perfino. Ma trovandosi la Comunità molto lontano dalla sua città di origine, questi episodi per fortuna trovarono contenimento negli stessi luoghi dove si erano determinati, ogni volta con rientri quasi immediati. Lo andammo a trovare più volte. Finchè -l’ultima- fu concordato un progressivo sgancio dalla struttura con reinserimento protetto in loco. Che, per buona sorte, parve funzionare per un lungo lasso di tempo.
Ebbi modo di incontrare Rodolfo una volta, anni dopo, in strada per caso; era tornato in città per certe sue vecchie faccende, e mi narrò le ultime vicissitudini, legate soprattutto allo stato di salute sempre più deteriorato. I vari insulti che aveva patito nel fisico, e nel morale, lo avevano profondamente minato, e in quel momento stava brigando, con l’aiuto del personale della Comunità con cui aveva mantenuto rapporti continui, per ottenere una pensione di invalidità dato che, nonostante l’età non certo avanzata, di mantenere una qualsiasi attività lavorativa era ormai fuori luogo poter parlare.
Gli feci i miei migliori auguri, e anche quella volta mi strinse forte la mano, con uno sguardo che faceva capire, come disse, di essere considerato da lui una delle rare persone in cui la fiducia che aveva riposto non fosse mai stata tradita.
Per questo oggi lo rivedo volentieri, Rodolfo.
Il collega mi ha informato che si trova ormai da alcuni anni in quella casa di riposo, nonostante sia ben al di sotto del limite di età previsto per essere ospitati in strutture del genere, a seguito di un progetto di assistenza mediato dai servizi sociali, in quanto soggetto bisognoso di cure e protezione incapace di vivere autonomamente. Nonostante il lungo periodo trascorso lontano da qui, non aveva mai voluto cambiare la residenza.
Quando mi apre la porta, faccio un tuffo nel passato: stessa faccia malandrina, stesso cappellino a visiera, stessa stretta di mano dell’ultima volta che ci siamo visti… Tutto solo molto molto più invecchiato e usurato.
D’altronde, anch’io, coi capelli bianchi, e ormai in pensione…
Dopo i convenevoli, i quanto tempo è passato, e allora come stai, il vecchio Rodolfo viene subito fuori, mentre ci accomodiamo in un angolo del salone-soggiorno: si mette a indicare questo o quell’ospite della residenza, mentre li saluta familiarmente, con un nomignolo, un epiteto, un ammiccamento dello sguardo.
“Eh quello lì… Oh, capitano. Sssì, altro che capitano!
E il geometra? Come va geometra stamattina? Sapessi perché geometra…”
“Beh, Rodolfo, come ti trovi qui?”
Non posso fare a meno di chiederglielo. E anche questa domanda mi riporta indietro negli anni, alle visite in Comunità; dove il Rodolfo di allora, al pari di quello d’oggi, ne aveva sempre da dire su tutti, cercando con quell’atteggiamento di porsi per quanto possibile fuori dal coro, come uno lì di passaggio, oggettivamente -secondo lui- diverso dai compagni di ventura, un pelo sopra a tutti, costretto a condividere un pezzetto di vita ma ben deciso a mantenere ben distinta dagli altri e dal contesto la sua irripetibile individualità. Una salvaguardia dell’Io allora comprensibile e scusabile, e che però andava analizzata e combattuta per non inficiare il processo di riflessione su di sé e sui propri errori, indispensabile per poter progredire poco a poco lungo le tappe del trattamento.
Ma ora?
Ora non c’è più in prospettiva nessuna “uscita”, nessuna “riabilitazione”, nessun “reinserimento”. Quel che è fatto è fatto. Qui dentro c’è solo da sopravvivere.
Difatti Rodolfo motteggia, ma non calca troppo la mano. Riconosce bene che questo è il suo ultimo approdo, e alla fin fine se ne dice soddisfatto, rassegnato al proprio destino.
Tuttavia non rinuncia ad un ultimo scatto di orgoglio: all’improvviso tira fuori la scatola di uno dei medicinali che assume per la terapia dell’AIDS, e brandendola davanti ai miei occhi proclama con enfasi teatrale: “Sai cos’è questa? Questa è la mia assicurazione contro la vita! Quando mi stuferò sul serio, basterà che invece di assumerle, le pastiglie le butto nel cesso. Loro non se ne accorgerebbero mai. E nel giro di qualche settimana me ne vado…”
Ammicca furbescamente rimettendo la scatola in tasca, e mi indirizza uno sguardo di intesa.
Sa che, al di là di tutto, io lo capisco. E -come sempre- non lo giudico.
“Allora, di’ un po’” mi decido ad un certo punto “cos’è questa storia di tuo figlio, per cui mi hai mandato a chiamare?
Innanzi tutto: non ne avevi perso le tracce?”
La trasformazione di Rodolfo appena sentite queste parole, che pure attendeva visto che erano la ragione del nostro incontro, è improvvisa e impressionante. Cade di colpo la maschera lisa, ma ostinatamente inalberata fino a quel momento, di guascone impenitente, per quanto ferito dal tempo e dalle intemperie, come quella di un capitano di ventura sopravvissuto a mille tempeste e per questo mai domato, e appare il viso di un vecchio rinsecchito precocemente, umiliato ed esiliato dalla vita, senza più nulla attorno cui aggrapparsi, se non i brandelli di un ruolo da eroe al quale ormai non crede più.
Inizia perfino a tremare un poco, quando con il dito indica un anziano personaggio chino su un pc da tavolo in un angolo del salone.
“Lo vedi quello?” dice. “Lo chiamiamo Smanettone. Passa tutto il suo tempo a navigare su Internet.
Qui ce n’è pochi che usano il computer, men che meno il cellulare, puoi capire… Nemmeno a me piace.
Lui invece, è la sua vita. Così poi ci riferisce le cose più strane, pettegolezzi, notizie, curiosità…”
Osservo con simpatia il vecchietto immerso nello schermo del computer.
“Un modo come un altro per tenersi vivo” dico, nell’attesa di capire dove voglia andare a parare Rodolfo.
Lui annuisce, l’aria assorta. Poi, finalmente:
“L’altro giorno ce l’aveva con quelli che si drogano…
Qui nessuno sa del mio passato” spiega abbassando la voce “tranne il dottore, si capisce.
Ho fatto un po’ di fatica a stare zitto. Ma poi ci ha fatto vedere una notizia: una serie di overdose che ha fatto impressione per il numero e la droga, una droga nuova, magari la conoscerai: il fentanil.
Abbiamo letto.
La città era quella dove se n’erano andati Rita e mio figlio. E c’erano le iniziali e le età dei ragazzi finiti in ospedale.
Uno di loro… uno di loro potrebbe essere Vittorio.”
Credo che a questo punto anche il mio viso sia invecchiato di colpo.
Mi sono reso conto tutto ad un tratto che durante i nostri incontri passati ci eravamo sempre dimenticati di suo figlio!
Io, perché era uscito troppo presto dalla sua storia, apparentemente senza lasciare tracce; lui, perché aveva sempre detto di aver rinunciato ad averne ogni possibile notizia. Per non fargli pesare i miei fallimenti, si giustificava.
Forse.
Ma intanto lui, il figlio, viveva, diventava grande, si fabbricava un destino.
Cosa gli aveva raccontato sua madre? Che era orfano? Che suo padre se n’era andato chissà dove?
Che non era mai esistito?
No, questo no: portava il suo nome.
“E’ solo un’idea” sta dicendo Rodolfo. “Ma dal momento che mi è venuto il sospetto, credilo, io non vivo più”.
Ogni generazione la sua droga, mi vien fatto di pensare.
Che il grande killer americano stia arrivando anche da noi lo sapevo bene. A suo modo il figlio ha raccolto l’eredità del padre? Non è servita a nulla, la fuga della mamma?
Possibile, un destino così, in qualche modo già scritto?
“Dai non è detto” provo a consolarlo. “Le iniziali, cosa vuoi…”
“Con un cognome come il mio? Che inizia per K? E proprio lì, dove sono andati a vivere?
E l’età?”
“Ma tu” provo a chiarire “tu non hai saputo proprio più niente di loro? Mai?”
Rodolfo abbozza, china gli occhi a terra.
“Ho saputo… ma tanti anni fa, eh? Ho saputo che non se ne sono mai andati via da lì.
Almeno Rita. Ha trovato da lavorare. Credo anche qualcuno con cui stare.
E Vittorio… No, di lui non ho mai più saputo niente. Nemmeno ho voluto sai?”
Raddrizza la testa.
Stiamo un momento in silenzio fissandoci negli occhi. E allora capisco.
Capisco che lui, quel figlio, se lo era dimenticato soltanto a modo suo.
Com’ero stato ingenuo, e superficiale: un padre, per quanto lontano e perduto per le sue strade, non può dimenticare davvero il proprio figlio. Se non altro per se stesso.
“Ci ho pensato tanto sai a lui? Specialmente tutte le volte che le cose andavano a rotoli.
Subito mi dicevo: meno male che non è qui a vedermi, meno male che non sa niente; meglio non avere un padre, che saperlo così. E anche: non avrei saputo tirarlo su, gli avrei fatto dei danni.
Ma poi mi volevo consolare: certo lui farà meglio di me. Ci vuol poco… Chissà, sua madre lo avrà messo a studiare, imparerà un mestiere, magari diventerà qualcuno…
Sai? Le fantasie di un padre. E siccome non avevo nessuna notizia, neanche ne ho mai cercate. Così potevo fare tutti i sogni che volevo.
Dicevo: riscatterà questa mia esistenza vuota, si farà strada.
O almeno lo speravo. Potevo sperarlo…”
Tace un momento, gli occhi persi nel vuoto.
“Adesso invece…”
Devo dire qualcosa.
“Dai Rodolfo, non è detto che sia proprio lui. E in ogni caso…”
Sapevo che mi avrebbe fulminato.
“Non prendermi in giro!
Se non è lui, pace. Ma me lo sento, che è lui!
Quel che mi importa adesso è sapere se è vivo, se è uscito dall’ospedale, cosa fa.
Sapere… se posso essergli utile in qualche modo…”
A dispetto del cipiglio feroce, ha le lacrime agli occhi.
Poi si riprende.
“Capisci? E’ per questo che ho chiesto di parlarti.
Qui dentro nessuno sa della mia storia, te l’ho detto, tranne il medico.
Allora sono andato da lui con la notizia, e gli ho chiesto se poteva mettermi in contatto con te. Di te io mi fido… Mi sono sempre fidato”.
“Ti ringrazio” rispondo commosso. “Ma cosa vuoi che faccia esattamente?”
Rodolfo cincischia un momento.
“Ecco” sputa alla fine il rospo. “Mi chiedevo se conosci qualcuno, laggiù: magari negli ospedali, o nei SerD della città…
Per sapere. Se non è lui… Ma non ci credo. E se è lui invece, può darsi che si sia rivolto a uno di loro, no? O che l’abbiano preso in cura dopo il ricovero.
Sempre che sia vivo…
Insomma pensavo: se conoscessi qualcuno, potresti chiedere notizie? A te le darebbero. Io non saprei come fare.
E poi, se lo trovi, forse potrei aiutarlo in qualche modo…
Magari mi illudo, magari è solo un’idea del piffero! Però non posso stare con le mani in mano. Devo sapere!
Che dici?”
Povero Rodolfo. Che posso dire?
Qualcuno laggiù forse potrei rintracciarlo, sì: colleghi conosciuti a convegni, o sentiti durante gli anni di lavoro per trasferimenti di utenti comuni fra Ser.D. Non sarà facile, ma posso provare.
Ci debbo provare.
Rodolfo ha colto l’istante di esitazione nei miei occhi, e si è già messo in posizione aggressiva.
“Ti domando troppo dottore?! Dopo tutti gli anni che ci conosciamo?”
Lo rabbonisco subito. Gli spiego le difficoltà della cosa, ma lo rassicuro che mi ci metterò d’impegno.
Solo, non posso garantire…
“Oh sta’ sicuro. Se non ce la farai non te ne farò una colpa.
Le colpe, in questa storia, sono tutte mie, lo so bene. Ma se mi puoi aiutare…”
Prometto che proverò.
Mi stringe forte la mano, con tutt’e due le sue. Trema un po’.
“Credevo” dice mentre mi accompagna all’uscita “credevo di restare in pace qui dentro, finchè non ne avessi avuto abbastanza. Adesso però…”
Mette la mano in tasca, e ne trae di nuovo la scatola con il farmaco per l’AIDS. Me la mette un’altra volta davanti agli occhi con mossa teatrale.
Ma stavolta forse non è teatro.
“Se mio figlio fa una brutta fine… la svuoto tutta nel cesso. La mia assicurazione sulla vita!”
Gli prendo un braccio, e facciamo l’ultimo tratto senza parlare.
Lo saluto sulla soglia.
“Adesso” fa a mo’ di commiato, con aria forzosamente allegra “adesso vado a fare la partita a ramino con l’avvocato. Mi sarebbe piaciuto, fare l’avvocato: di legge in fondo me ne intendevo…”
Sorridiamo. Esco all’aria libera. La porta a vetri si richiude con un tonfo sordo.
Scorgo la sagoma di Rodolfo che mi osserva andare via.
Come quando ci salutavamo ai cancelli della Comunità.
Riuscirò ad aiutarlo un’ultima volta?
Gli uccellini nell’aria cantano liberi e spensierati.
Accidenti a te, Rodolfo. Mi hai messo in un bel pasticcio.
Un autentico caso di coscienza, non c’è che dire.
Forse la cosa migliore sarebbe non fare niente. Poi ti dirò che non sono riuscito ad avere notizie: mettiti il cuore in pace, se fosse accaduto il peggio ti avrebbero avvertito, sei pur sempre il padre.
Ma so già che non ne sarò capace. Ho lavorato tutta la vita per ridare speranza alle persone che si rivolgevano a noi, non posso tradire adesso.
E se scopro il peggio? Non metto Rodolfo nella condizione di farsi del male, come ha voluto ben farmi vedere?
O quello era solo un gesto?
Scuoto la testa, scrollo le spalle.
Un padre mi ha chiesto aiuto. Un figlio forse potrebbe ritrovare il genitore: una persona che, oltre tutto, al netto degli sbagli fatti sembra finalmente un poco più consapevole delle dovute responsabilità.
Vale la pena di provare.
Poi tanto, lo sappiamo, le cose vanno come devono o vogliono andare.
Farò come meglio potrò, in base a quel che riuscirò a scoprire.
Chi era già quel collega tanto simpatico che lavorava laggiù?
Ecco, sì. Comincerò da lui.
E che Dio ce la mandi buona. A tutti.
Scritto da Alberto Arnaudo.