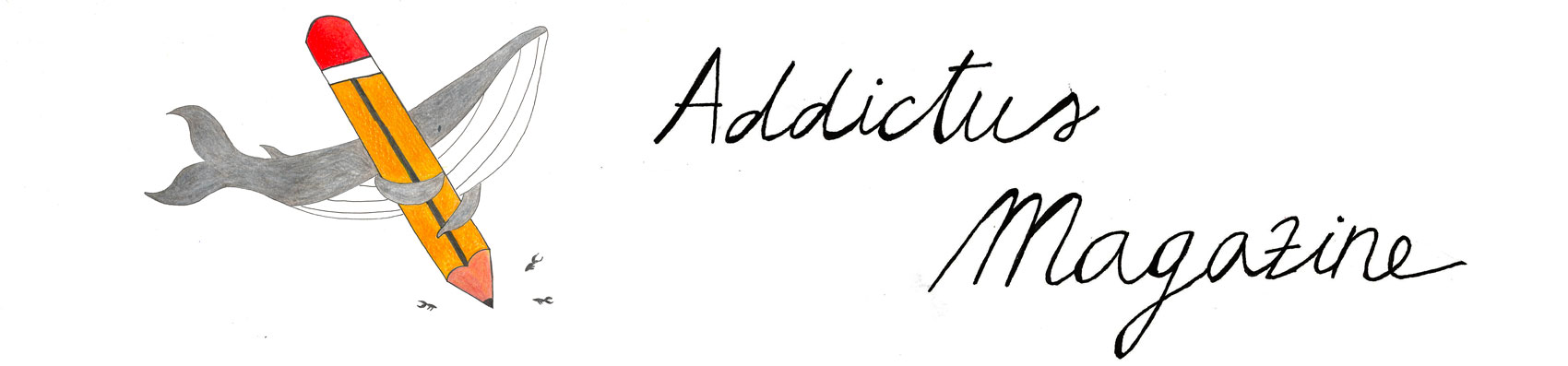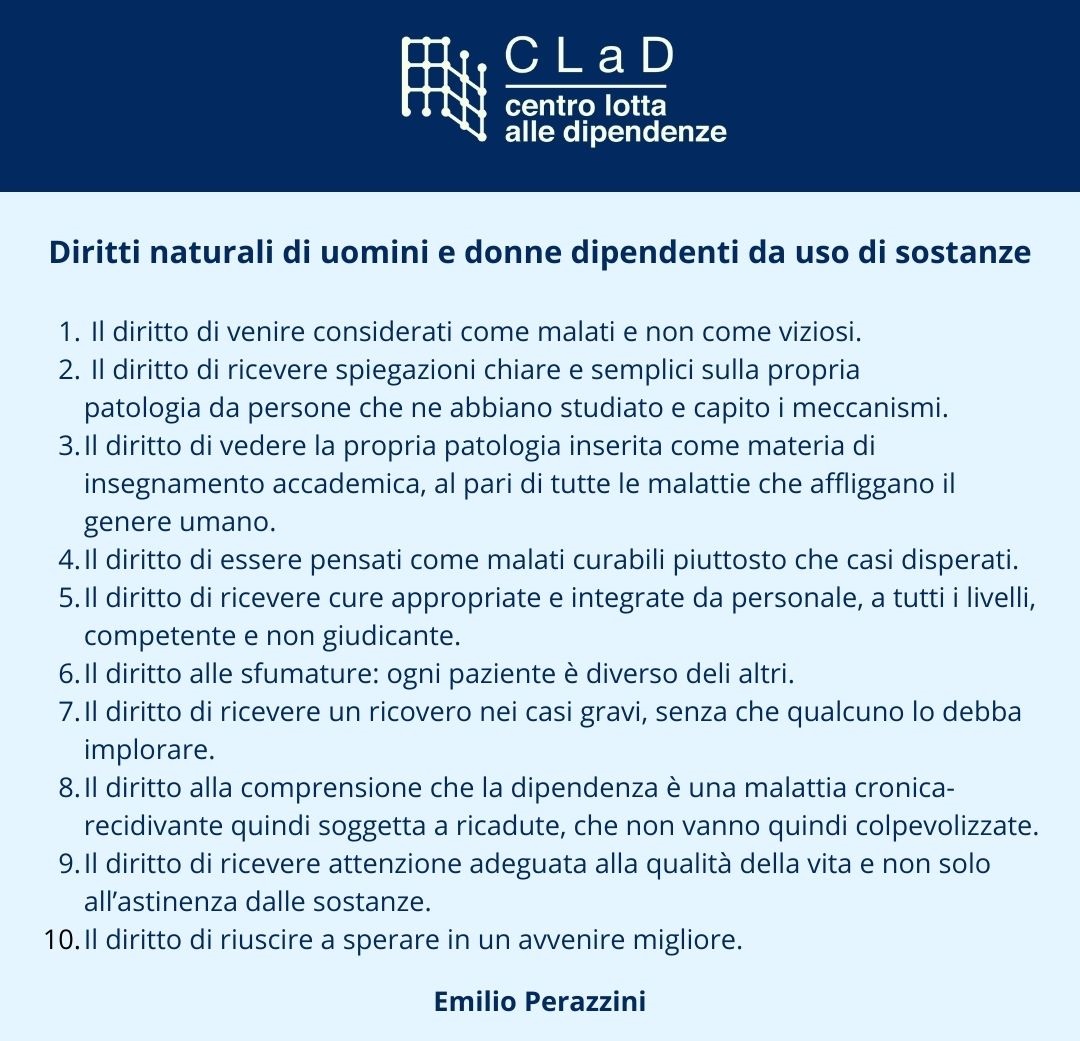L’ultima mano

Conoscevo Giovanni Molon da una vita. Da bambini eravamo amici, come possono esserlo il figlio di un proprietario terriero e quello del suo mezzadro. Eravamo compagni di classe, alla domenica ci recavamo insieme a pescare al torrente e, quando c’era abbastanza caldo, facevamo il bagno nel canale. Ci eravamo persi di vista dopo le scuole elementari, poiché grazie a una borsa di studio avevo proseguito i miei studi in un’altra regione. Ero tornato a vivere al paese molti anni dopo, quando ormai ero diventato un oculista affermato e avevo aperto uno studio nella città vicina.
All’epoca Molon era subentrato al padre nella gestione dei campi, inoltre aveva acquistato nuovi terreni, accrescendo le proprie ricchezze. Era stato il primo in paese a comprare il televisore, il frigorifero e la lavatrice. Qualsiasi cosa la moglie chiedesse, lui gliela comprava.
Una sera di novembre, quando la nebbia avvolgeva con uno strato lattiginoso le persone e i luoghi, ci incontrammo lungo il corso principale.
“Luigi, amico mio, è da un pezzo che non ci si vede!” esclamò, stringendomi in un abbraccio fraterno.
“É proprio vero, Giovanni” risposi. “Mi sono trasferito qui due mesi fa con la mia famiglia e contavo di farmi vivo, prima o poi. Sai come è, il lavoro, gli impegni…”
Le mie giustificazioni suonavano ridicole alle mie stesse orecchie, chissà come dovevano apparirgli insignificanti. Molon, però, mi sembrava fin troppo allegro per porsi certe domande o per essere veramente interessato alle mie parole.
“Vieni a bere qualcosa da Franco?” mi chiese a bruciapelo.
Franco Gioiosi gestiva l’unico bar del paese e aveva la sinistra nomea di usuraio. Nel retro del suo locale si giocava d’azzardo e molti si erano indebitati con lui. Non vedevo di buon occhio Franco, ma erano tanti anni che avevo perso i contatti con Molon e decisi di accettare l’invito. Ci sedemmo a un tavolino e, ordinata una bottiglia di Lambrusco, ci raccontammo gli eventi degli ultimi vent’anni.
“Giochi a briscola?” mi domandò all’improvviso. Avevo notato in lui una certa tendenza a saltare di palo in frasca, senza seguire un apparente filo logico.
“Con mia moglie e alcuni amici, ogni tanto.”
“Mi segui nel retrobottega? Siamo tra amici, un quinto giocatore è sempre il benvenuto.” Mentre mi lanciava questa proposta aveva cambiato espressione: le pupille si erano dilatate, le orecchie sembravano all’erta.
“Non ho intenzione di giocare e puntare soldi, ma potrei assistere alla partita.”
In quel momento un uomo appena entrato nel locale si avvicinò a noi. Alto e dinoccolato, sui quarant’anni, aveva la barba incolta e la fronte solcata da rughe. Indossava un cappotto liso, che si sfilò rivelando una camicia sdrucita sui gomiti e un gilè al quale mancavano un paio di bottoni.
“Signor Molon, tra cinque minuti iniziamo” disse, per poi scivolare oltre la stretta porticina che conduceva nel retro del locale.
Quando si allontanò, notai che i suoi pantaloni erano stati rattoppati.
“Si tratta di Bianchini, uno dei miei mezzadri”, commentò Molon. “L’anno scorso il raccolto gli ha reso pochissimo e per pagarmi ha ridotto i suoi risparmi all’osso.”
Evitai di fargli notare che anch’io ero figlio di mezzadri e ingoiai il mio malumore. Non avevo mai assistito a una partita clandestina e mi consumavo dalla curiosità. Molon se ne accorse. Insistette per pagare la nostra consumazione e mi disse di entrare per primo nel retrobottega.
Al suo interno vi erano uno stretto tavolo quadrato circondato da quattro sedie in legno sgangherate. A mala pena ci si vedeva; sollevai lo sguardo e vidi che dal soffitto penzolava una lampadina che emetteva una luce fioca.
“Buonasera” dissi avanzando con cautela nella stanza semibuia e accomodandomi su un alto sgabello.
“Buonasera” rispose un coro di voci.
Studiai con più attenzione la scena. Attorno al tavolo da gioco vi erano, oltre a Bianchini, altre due persone: un uomo molto distinto, con un completo gessato e la cravatta blu scuro, e una giovane donna, che nascondeva i capelli sotto un foulard di seta a motivi floreali e indossava un paio di occhiali da sole dalla montatura color argento che le copriva buona parte del volto. Benché fosse così camuffata, aveva un’aria vagamente familiare.
Questi due individui apparivano completamente fuori luogo in una bisca clandestina di provincia, ma la sfida si presentava interessante.
“La regola è chiara: non si gioca a coppie, ma singolarmente”, rammentò l’uomo dal gessato, con voce tonante. “La posta in gioco iniziale è di diecimila lire a testa.”
Ognuno mise i soldi sul tavolo e la donna tagliò il mazzo; la briscola era coppe. Molon era un giocatore esperto, le carte erano buone e vinse senza difficoltà.
“Nuova posta in gioco, ventimila lire a testa!” disse, guardandosi intorno con un sorriso pieno di soddisfazione.
Vidi un lampo di disagio attraversare lo sguardo di Bianchini. “Ce le ho a casa, intanto te le registro sul foglio.”
Gli altri partecipanti, invece, misero i soldi sul tavolo senza battere ciglio.
“Il vincitore stabilisce la posta in gioco” mi spiegò Molon sottovoce, mentre Bianchini distribuiva le carte.
Uscì denari. Anche in questa occasione il mio amico stracciò i suoi rivali.
“A denari vincono i ricchi!” disse con soddisfazione.
Partita dopo partita, assistevo a una serie di schiaccianti vittorie di Molon. Alla fine della serata vinse un’incredibile quantità di denaro, tra contanti e fogli che attestavano l’importo che gli spettava.
“Chiedo un prestito a Franco e ti ridò tutto”, mormorò Bianchini, con la testa china.
Molon accese un sigaro, emise una nuvoletta di fumo e, alzando le spalle, disse che non c’era problema, loro due si conoscevano bene, sapeva che era uomo d’onore.
Bianchini si allontanò mogio mogio, io mi incamminai verso l’uscita insieme al mio amico.
“Non sono affari miei, ma non condivido tutto questo.”
“Vuoi farne una questione religiosa, come fa mia moglie? Però, quando le arriva qualche ninnolo lo accetta sempre volentieri.”
“Non sono un moralista, ma non saresti il primo che si rovina a carte.”
“So quello che faccio.”
Iniziavo ad essere irritato per l’atteggiamento superficiale che dimostrava. “É quello che dicono tutti.”
“Hai visto gli altri due giocatori?” domandò nel tentativo di sviare la conversazione.
“Sì, certo.”
“Lui è un imprenditore, viene fin qui per non farsi riconoscere.”
“Lei, invece? Ha un viso noto, ma non riesco a ricordarmi dove l’ho incontrata.”
“Ti dirò questo: lavora a Cinecittà.”
“Ecco perché mi pareva di averla già vista! Ma viene fin qui?”
“Certi peccatucci veniali devono rimanere ben nascosti, caro mio! Immagina che scandalo se si venisse a sapere…”
Eravamo ormai giunti al bivio che separava la via di casa mia, nel centro del paese, da quella che conduceva verso il suo podere.
“Ci vediamo presto, d’accordo?” mi salutò. “Non devono più trascorrere vent’anni senza che ci si riveda!”
Le settimane successive fui molto impegnato per il lavoro. A parte questo, volevo prendere le distanze da Molon e dal suo vizio.
Una domenica ci incontrammo a messa.
“Vieni da Franco stasera?” mi domandò al termine della funzione. “Mi è toccato venirti a stanare in chiesa, bigotto che non sei altro!”
Messo all’angolo, non potei che accettare l’invito e concordammo che ci saremmo incontrati nel retrobottega.
Al mio arrivo mi appollaiai su uno sgabello posto alle spalle dell’imprenditore vestito in gessato. Quando entrò Bianchini rimasi colpito dal suo aspetto spaventoso: aveva gli occhi rossi, profonde occhiaie e un colorito cinereo.
Mi alzai dalla mia postazione e andai a raggiungerlo.
“Non ha una bella cera, signor Bianchini. Dovrebbe tornare a casa o, ancora meglio, andare da un medico.”
“E con cosa lo pago il dottore?”
“Una visita molto rapida gliela posso fare io, se si fida di un oculista. In caso di problemi seri, troveremo una soluzione.”
“Devo a Franco uno squinterno di soldi, mi tocca vincere a tutti i costi stasera.”
Visto che era impossibile convincerlo a ritornare a casa, mi ritrovai ad augurargli buona fortuna e tornai alla mia postazione. Molon arrivò poco dopo e mi venne incontro.
“Oh! Meno male che sei venuto, vecchio mio! Temevo che mi tirassi un bidone.” Si rivolse poi all’imprenditore. “Mi è toccato andare in chiesa apposta per pregarlo di venire, io che non prego nemmeno i santi!”
L’attrice di Cinecittà arrivò per ultima, e si sedette al tavolo.
“Prima puntata: diecimila lire a testa” disse con la sua voce vellutata.
La briscola era bastoni. I quattro giocavano con un ritmo forsennato, sembrava che avessero fretta di passare alla partita successiva. Era quasi difficile riuscire a seguirli, impegnati come erano in una lotta contro il tempo.
Franco si affacciò nel retrobottega.
“Come andiamo?” chiese, ma sarebbe stato più esplicito se avesse detto: “Bianchini sta vincendo?”
Per buona sorte, quella sera la dea bendata andò in soccorso di Bianchini, che fece man bassa e riuscì a sanare il debito con Franco. Finalmente lo convinsi a tornare a casa, dicendogli che sarei passato a visitarlo l’indomani mattina, prima di recarmi in città.
Feci un tratto di strada con Molon, che quella sera aveva perso un certo quantitativo di soldi.
“Non sono preoccupato, eh. Ho tutto sotto controllo” disse, prima che potessi aprire bocca.
“Non conosco i tuoi affari, ma fermati finché sei in tempo.”
“Stasera è andata male, ma ho ancora da parte le vincite contro Bianchini”, fece una pausa per accendersi un sigaro. “Lo sai che aveva dovuto chiedere un prestito a Franco per potermi pagare?”
“Me lo ha detto, e spero che dopo stasera smetta per sempre di giocare.”
“Io non smetterò mai.”
Lo guardai. Per un attimo rividi in lui il bambino che aveva catturato un luccio a mani nude.
“Sei un imbecille, te lo dico senza tanti complimenti.”
“Le carte mi stimolano, mi fanno sentire vivo. Vincerò o perderò? La mia bravura sarà sufficiente o gli altri giocheranno meglio di me?”
“C’è tanta gente che gioca a carte senza puntare soldi!”
“Ma sono i soldi che mi danno il brivido per continuare a giocare.”
“Molon, temo che tu abbia una dipendenza molto forte per il gioco d’azzardo. Posso aiutarti a uscirne, ma il grosso dello sforzo devi farlo tu.”
“Il gioco mi fa sentire vivo, te l’ho detto.”
“Tu non ne hai bisogno.”
“Invece sì. La mia vita fa schifo.”
Lo guardai sgomento. Avrei voluto gridargli in faccia che era un’assurdità, visto tutto quello che possedeva, ma mi limitai a domandargli: “Perché dici questo?”
“Ho ereditato il podere da mio padre, il mio lavoro nemmeno mi piace. Tu hai studiato all’università, hai potuto seguire i tuoi sogni e hai raggiunto grandi traguardi. Ti ammiro molto, lo sai?”
“Ti ringrazio, ma esageri.”
“Vero è che io sono bloccato dentro un’esistenza che qualcun altro ha deciso per me.” Fece una lunga pausa per raccogliere le proprie idee. “Sarei voluto diventare un contadino, un artigiano, insomma avrei desiderato sporcarmi le mani, se capisci quello che intendo.”
“Non hai potuto scegliere liberamente e questo è frustrante, ma ricordati che un contadino o un artigiano conducono una vita molto più semplice della tua.”
“Cosa vorresti dire?”
“Che non avresti di certo la televisione, nemmeno la lavatrice, il frigorifero o la nuova 1500 Cabriolet OSCA.”
Sorrise orgoglioso. “Hai saputo del mio nuovo gioiellino?”
“Sì. Ti posso assicurare che persino in città ne ho visti pochi esemplari.”
Eravamo arrivati al punto in cui di solito ci separavamo.
“Ti ringrazio per le tue parole. Rifletterò su quello che mi hai detto.”
Ci salutammo e lo guardai allontanarsi dal centro abitato, a capo chino e ingobbito.
Il mattino dopo mi recai da Bianchini e lo visitai. Aveva un colorito roseo, decisamente il suo aspetto era migliorato rispetto alla sera precedente.
“Sembra solo un raffreddore. Cerchi di stare a letto a riposo per un paio di giorni”, gli dissi dopo aver terminato la visita.
“Sto già molto meglio, dottore. Il gioco mi aveva rovinato la salute. Ho deciso di smettere per sempre.”
Fui molto soddisfatto per quelle sagge parole. Bianchini sembrava intenzionato a rigare dritto, come se avesse colto la pericolosa associazione tra dipendenza dal gioco e salute fisica.
Chi, invece, era ben lungi dall’interrompere le proprie puntate a briscola era Molon. Al posto di Bianchini, ormai definitivamente ritirato dalle competizioni clandestine, era arrivato Gilloni, un pugile dilettante che traeva i suoi guadagni dalle lotte su ring improvvisati. Il naso rotto, la mascella lussata e la mancanza dei denti incisivi mi suggerivano che la sua specialità consistesse nell’incassare i pugni anziché tirarne agli avversari.
Nonostante le sue dubbie capacità pugilistiche, mostrava un grande talento nel giocare a carte. Le sue manovre erano fulminee. Le carte scivolavano lisce come l’olio, le partite si avvicendavano con la rapidità della luce. Molon faticava a ricordare quali carte fossero già scese e quali, invece, fossero ancora nel mazzo. Per la prima volta il mio amico fu in serie difficoltà.
“Hai fretta di chiudere la mano?” domandò a Gilloni dopo l’ennesima partita, con un sorrisetto teso. Cercava di scherzare, ma si capiva che era molto a disagio.
“Mi piace vincere. La velocità fa parte della mia strategia” rispose con un tono sicuro.
“Eh, la grinta dei ventenni…” commentò l’imprenditore. “Ragazzo mio, vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo. Alla tua età te lo puoi permettere!”
Seguì una nuova mano a briscola, poi un’altra e un’altra ancora. Gilloni continuava a vincere. La diva di Cinecittà ipotizzò che le carte fossero truccate. Mi venne chiesto di effettuare un controllo per verificare un’eventuale irregolarità del mazzo. Passai al vaglio una carta alla volta: non c’erano segni, pieghe o altro che potessero renderle riconoscibili. Le restituii il mazzo.
“Sono spiacente, ma per me si è fatto tardi”, tagliò corto. Si alzò frettolosamente dal suo posto, lasciò sul tavolo tutti i soldi che aveva perso, si aggiustò alla meglio il foulard, indossò il cappotto e uscì con un gesto secco, senza nemmeno salutare.
Pochi minuti dopo, Franco si affacciò.
“Avete perso una concorrente molto forte. Dubito che la rivedrete nei prossimi giorni”, osservò.
“Quando il gioco si fa duro, i duri scendono in campo”, fu la lapidaria risposta di Gilloni.
Il ragazzo non mi ispirava simpatia, ma ero ipnotizzato dal suo stile, dalla spavalderia e dalla nonchalance che dimostrava quando le sue carte venivano “strozzate” dagli avversari.
Se Gilloni mostrava sicurezza e pieno controllo di sé, Molon annaspava. Continuava a perdere, partita dopo partita. Mi ero avvicinato un paio di volte suggerendogli a bassa voce di ritirarsi, ma in entrambe le occasioni mi aveva allontanato con un gesto spazientito della mano.
“So quello che faccio, non impicciarti” sembrava volermi dire con il linguaggio del corpo.
A fine serata Molon aveva perso una quantità ingente di denaro. Versò il contante che aveva a disposizione e scrisse di suo pugno un foglietto che diede a Gilloni, su cui era riportata la cifra che gli doveva.
“Signori, è stato un piacere giocare con voi. Arriva però il momento in cui un gentiluomo sa quando è ora di ritirarsi” disse l’imprenditore di città, lanciando un’occhiata molto eloquente a Molon. Da buon compagno di gioco voleva metterlo in guardia per evitargli di finire nel baratro.
Al momento di salutarci, ci stringemmo la mano.
“Tenga d’occhio il suo amico, dottore”, sussurrò quando mi fu vicino.
“Farò del mio meglio” borbottai, ma sapevo che non sarebbe stato facile convincerlo a smettere di giocare.
Trascorsero due giorni. Avevo appena congedato il mio ultimo paziente quando la segretaria si affacciò alla porta del mio ambulatorio.
“Un uomo chiede di lei, dice di essere un suo amico.”
Uscii sul corridoio e mi ritrovai faccia a faccia con Molon. Lo invitai nel mio studio e lui si accomodò sulla sedia di fronte alla mia scrivania. Era scarmigliato e aveva due profonde occhiaie.
“Hai una pessima cera. La situazione è più grave di quanto non pensassi, vero?” gli domandai.
“Sono nei guai. Ho dato tutto il liquido che avevo a quel pugile da strapazzo. Adesso devo andare in banca e sentire se possono farmi un prestito per saldare il resto del conto.”
“Ho cercato di fermarti l’altra sera e l’imprenditore è stato molto esplicito. Devi smettere di giocare o ti rovinerai.”
“Sono già rovinato. Puoi venire con me in banca? Se mi vedono arrivare accompagnato da una persona rispettabile ho più possibilità che mi ascoltino.”
La spedizione in banca si rivelò disastrosa. Molon aveva dilapidato un intero patrimonio nel giro di poche settimane. L’unico bene che gli rimaneva era il suo podere, sul quale però era già stata aperta un’ipoteca. In altre parole, su di lui gravava la spada di Damocle di ritrovarsi senza un tetto sulla testa.
“Il podere rende bene, sarai in grado di saldare l’ipoteca” provai a consolarlo quando uscimmo in strada. “Però devi smettere di giocare, non puoi finire ancora più nella merda.”
Mi guardò con un’espressione da cane bastonato. “E i soldi che devo a Gilloni?”
“Digli di pazientare, arriverai a pagarlo. L’importante è che tu smetta di giocare.”
“Te l’ho detto, il gioco è ciò che dà un senso alla mia vita.”
Quell’uomo non aveva nulla a che fare con il mio amico d’infanzia. Si rendeva conto che la situazione era disperata, ma non era disposto a fare nulla per uscirne. Mi spazientii. “Mi dispiace, ma non ho intenzione di assisterti mentre ti rovini con le tue stesse mani.”
“Cosa vorresti dire?”
“Che ho cercato di aprirti gli occhi, ma non voglio assistere alla tua distruzione. Le nostre strade si dividono qui.”
E me ne andai, lasciandolo in mezzo alla strada.
Mi comportai male? La risposta è sì. Tuttavia ero talmente amareggiato con lui e arrabbiato con me stesso per non averlo saputo aiutare che avevo bisogno di prendere le distanze dal suo atteggiamento autolesionistico.
Nelle settimane successive girai ben alla larga dal bar di Franco ed evitai come la peste le occasioni in cui avrei potuto incontrare Molon. Venni però a sapere dalle voci di paese che il mio amico aveva impegnato i gioielli che aveva donato alla moglie e che, dopo il buco dell’acqua con la banca, aveva chiesto un prestito a Franco per continuare a giocare. La moglie aveva deciso di andarsene di casa, portando con sé i figli.
“Vuole denunciarmi per abbandono del tetto coniugale? Faccia pure!” aveva detto alle amiche più care. “Ha perso tutto. Non voglio che i miei bambini vedano il padre ridotto in mutande e che siano costretti a mangiare pane e cipolle. Me ne ritorno dai miei genitori!”
Ero dispiaciuto per quanto occorso a Molon, ma comprendevo la scelta della moglie. Del resto, privato della presenza della famiglia, si gettò con ancora più foga nel gioco. Seriamente preoccupato e pentito per il mio comportamento, un sabato pomeriggio andai a trovarlo a casa sua. Quando mi aprì la porta rimasi impressionato dal suo aspetto.
“Ciao Luigi, bentornato”, disse con un tono rassegnato. Era vistosamente dimagrito, le spalle erano incurvate. Aveva la barba incolta e lo sguardo spiritato, non sembrava del tutto in sé.
Cercai di dissimulare lo stupore che provai nel vederlo ridotto così. “Vieni con me in città. Un mio amico è specializzato nella cura degli esaurimenti nervosi”, provai a convincerlo.
“Pensi che sia impazzito e vuoi farmi rinchiudere in un manicomio,? Non ci casco”. Il tono della sua risposta era sprezzante, ma non mi arresi.
“Non sei matto, hai solo bisogno di aiuto.”
“Nessuno può aiutarmi. Mi servono solo le carte.”
“Sei irriconoscibile. Devi ritornare in te prima che sia tardi. Bianchini ce l’ha fatta, puoi farcela anche tu.”
“Ho già perso mia moglie e i miei figli. Non ho più nulla. Al debito con la banca si è aggiunto quello con Franco. Lasciami in pace e vattene.”
Per un istante, rividi una scena della mia infanzia. Io e Molon, a circa sei anni, impegnati a dare la caccia alle lucciole in una calda serata estiva. Scossi la testa e, seppur addolorato, non potei fare altro che andarmene.
Nei giorni seguenti mi intrattenni sempre più spesso in città. Infilavo una visita dopo l’altra, volevo immergermi nel lavoro e cercare di reprimere il più possibile il rimorso nei confronti di Molon.
Quel sabato, non appena l’ultimo paziente fu uscito, qualcuno bussò alla porta dell’ambulatorio.
“Avanti!”
La mia segretaria fece capolino. “Dottore, scusi se la disturbo, ma c’è sua moglie all’altro capo del telefono.”
Mi alzai di scatto per raggiungere l’apparecchio telefonico. Temevo una disgrazia: mia moglie non mi telefonava mai quando ero al lavoro perché non voleva disturbare.
“Non ci crederai mai!” furono le sue prime parole. Anche se eravamo distanti potevo figurarmela con gli occhi sgranati e un’espressione incredula.
“Cosa succede?”
“Franco Gioiosi è stato trovato morto nel suo bar!”
“Cosa?! Ma come è possibile?”
“Aveva un coltello piantato nel cuore. Il suo garzone lo ha trovato a terra stamattina immerso in un lago di sangue.”
“Si sa chi è stato?”
“Si fa il nome del tuo amico Molon.”
“Molon non è un assassino!”
“Forse no, ma in paese si dice che avesse un debito di cinquanta milioni con Franco.”
Rimasi sbalordito: non mi sarei mai aspettato una cifra così esagerata. Fino a pochi mesi prima Molon era ricco sfondato, ora invece era scivolato nell’indigenza più nera. La moglie di Bianchini affermava che tempo prima gli aveva donato due carote e una rapa! Lei, la moglie del mezzadro, aveva fatto la carità al proprietario terriero! Mi affrettai a tornare a casa. Venni a sapere che Molon era stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario ed era stato portato in caserma in attesa di convalida del fermo. Il bar era sotto sequestro.
Il funerale di Franco si tenne in forma strettamente privata. La sua cattiva fama di usuraio lo precedeva. Se era vero che molti frequentavano il bar perché era l’unico che ci fosse in paese, era altrettanto vero che prendevano le distanze dalle sue attività illecite. Venni a sapere che alla funzione erano presenti solo il sacerdote e i parenti più stretti.
La settimana successiva chiesi il permesso di visitare Molon in carcere, dove si trovava in attesa del processo. Immaginavo che fosse più a suo agio lì che non a casa sua: se non altro riceveva due pasti al giorno e aveva un tetto sopra la testa, mentre al paese aveva perso tutto. Quando fu condotto al parlatorio lo trovai prostrato, con la fronte solcata dalle rughe e i capelli completamente imbiancati. Le spalle erano cascanti e lo sguardo era apparentemente perso nel nulla, ma quando lo salutai si dimostrò contento di vedermi.
“Avevi ragione tu. Dovevo fermarmi quando ero in tempo.” Mi disse, non appena fummo faccia a faccia.
“Mi dispiace, non avrei dovuto piantarti in asso quando eri così in difficoltà.”
“Tu hai provato ad aiutarmi, ero io che non ti ascoltavo. Ho perso tutto e ho ammazzato una persona per un debito di soldi. Avrei dovuto imparare da Bianchini, invece non mi sono riuscito a trattenere.”
Dimostrava una lucidità nel ragionamento che non aveva mai mostrato negli ultimi mesi. Pensai che fosse rinsavito, seppur troppo tardi.
“Non ha senso piangere sul latte versato.”
“Probabilmente no, ma ciò non toglie che io abbia fallito miseramente.” Fece una pausa. “Vorrei chiederti un favore.”
“Ma certo, dimmi pure.”
“Scrivi la mia storia. Racconta quello che mi è successo. Fa’ vedere che chi si impegna come Bianchini può, seppure a fatica, riuscire a smettere. E fa’ vedere che invece io sono scivolato sempre più in basso, e che questa è la mia fine.”
Così dicendo, crollò il capo.
La guardia venne a chiamarmi: il tempo a disposizione per il colloquio era terminato.
Salutai il mio amico, che mi congedò con uno sguardo pieno di malinconia.
Non fui sorpreso quando, un paio di giorni dopo, lessi sul giornale che si era impiccato nella sua cella, usando come cappio la cinghia dei suoi pantaloni.
Scritto da Alessandra Ferretti.