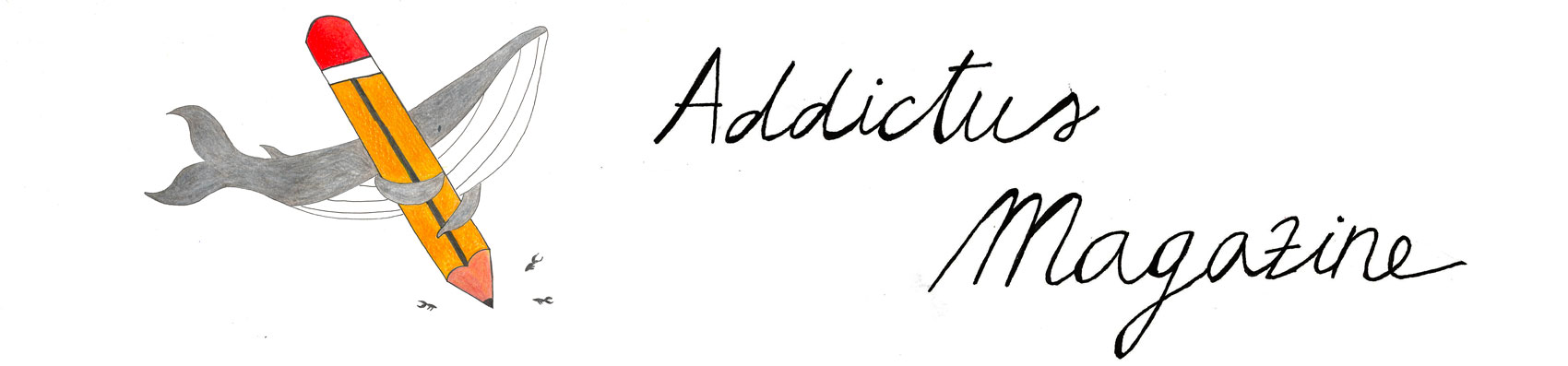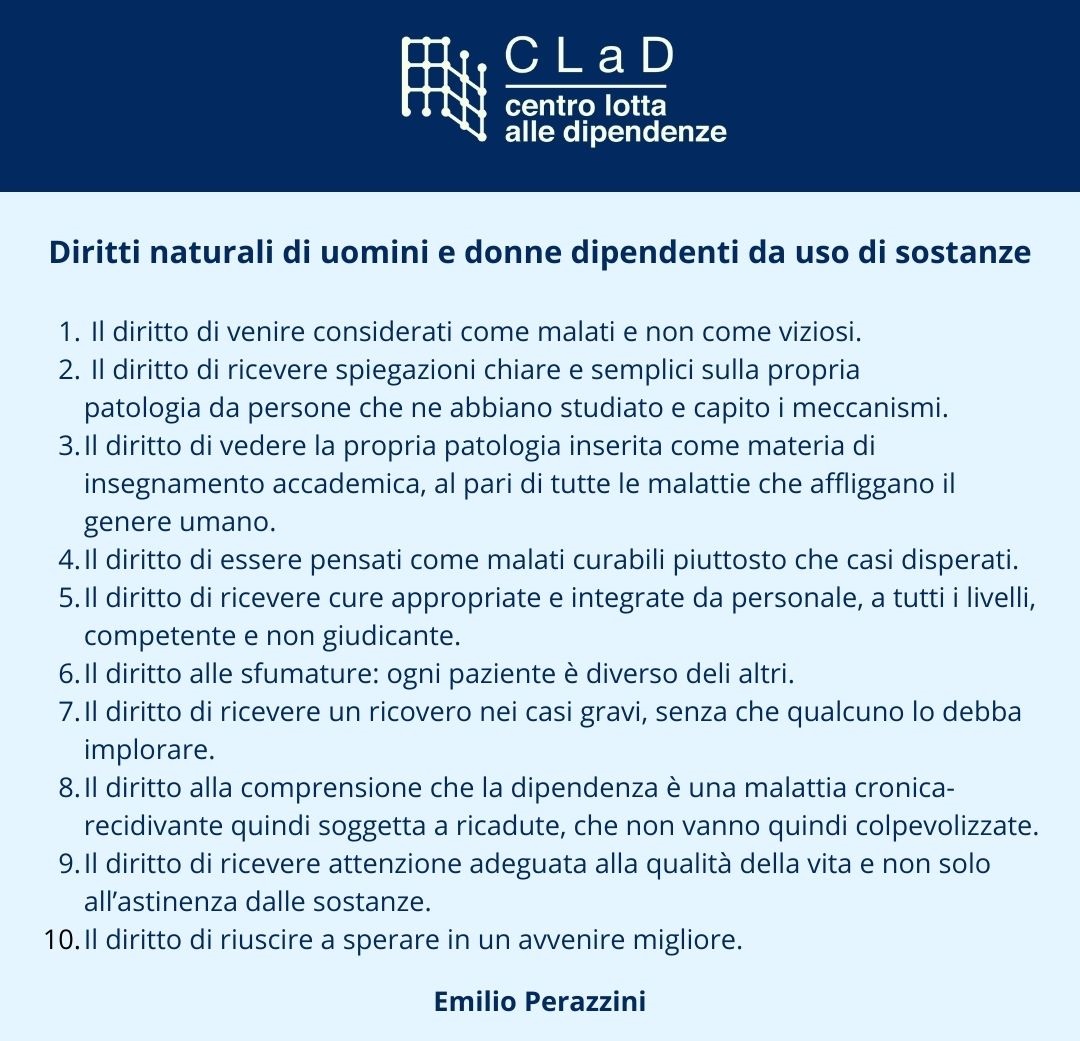Voluntas

Non è questione di volontà.
Trattasi di malattia professionale, che è una cosa molto diversa. Se non avete mai fatto questo mestiere non potete capirlo. E allora giù a giudicare da bravi benpensanti. I soliti discorsi da primi della classe: quelli che rigano sempre dritto, quelli che non cedono mai alle tentazioni, quelli che sono più forti delle proprie debolezze. Bella frase del cazzo, direte: se si è più forti delle proprie debolezze significa che non si hanno debolezze. Chiaro come il sole. A meno che la debolezza, in quel caso, non consista proprio nel non averne nemmeno una. Rigidi come manici di scopa. Che prima o poi si spezzano, quantèveroiddio! potete scommetterci. È solo questione di tempo, tutti i nodi vengono al pettine. Non pensiate che io sia l’unico scemo: la differenza tra me e voi è che io ne sono consapevole, mentre voi preferite raccontarvi la bella favoletta del va tutto bene. Ma sapete quanti ne ho visti saltare in aria, di signori-va-tutto-bene? Lasciamo stare, è un discorso che non mi va di fare. Anche perché sarebbe fatica sprecata ed io sono già stanco morto.
Cammino tutto il giorno, porcomondo. Anzi, per metà giornata e per metà della notte. Anche questo fa parte del mestiere. Viviamo in una terra di mezzo, non esiste altro animale che abbia questi orari assurdi. Questa fisiologia alterata da mezzo cane e mezza civetta. Un motivo ci sarà se la natura ha scelto per una bipartizione netta. Solo i gatti, che io sappia, hanno orari simili ai nostri. Ma dormono sedici ore al giorno, mentre noi molto meno. E quando sono svegli fanno il cavolo che gli pare: c’è una bella differenza. Noi ci svegliamo col sole già alto, intontiti dalle ore piccole; ci barcameniamo negli strascichi del mattino cercando di conservare intatte le energie per le fatiche della sera. Viviamo al risparmio, smaltendo come i vecchi, sulle panchine dei parchi deserti, i tre veleni che ci intossicano l’esistenza: il mal di piedi, l’alcool e le umiliazioni costanti.
Dei tre, l’alcool è di gran lunga il male minore. Il pharmacon, potremmo dire, che ci permette di tirare avanti per un’altra notte. Perlomeno solleva lo spirito, anche se poi al mattino ti ritrovi sempre sul fondo del pozzo. Ti ci sei cacciato di tua volontà, non puoi nemmeno lamentarti. Ma trovatemi una soluzione diversa.
Siamo camerieri, se non l’aveste capito. Un popolo invisibile di avulsi dalla società. All’apparenza perfettamente integrati, uno dei tanti ingranaggi del sistema, ma all’atto pratico viviamo come fantasmi. Abbiamo orari diversi dal resto del mondo, stacchiamo la spina quando ormai è già notte alta, ci frequentiamo soltanto tra noi. E come il calzolaio ha sempre per le mani suole e tomaie, il sarto stoffe e rocchetti, noi maneggiamo costantemente bicchieri e bottiglie di vini più o meno buoni, più o meno pregiati: ne consegue che essere alcolisti per la maggior parte di noi è una condizione naturale. Oltre che una specie di dovere professionale. Assaggiare tutto l’assaggiabile, intendo, per una questione di competenze. La direzione non offre degustazioni gratutite, figuriamoci, e dunque. Poi al cliente siete voi che dovete raccontare il vino, come usa dire oggi, e se non avete la minima idea di quello che servite sono affari vostri. Io per rifilare qualcosa ho bisogno di conoscere, sennò perdo di credibilità prima di tutto di fronte a me stesso. Ho una mia etica.
E poi volete mettere la rivalsa? Il piacere ribelle di impossessarsi finalmente di ciò che per tutto il tempo del servizio hai offerto sgambettando a centinaia di gaudenti sconosciuti. Quando finisce l’orario cerchi di rifarti, di tutte le bottiglie che non hai potuto assaggiare ma soltanto odorarne i sugheri. Cerchi di rifarti di tutta la vita che non hai vissuto.
Provateci voi. Dalle tre del pomeriggio in piedi a sistemare tavoli, cambiare fusti, darci dentro di strofinacci, togliere la polvere da ogni recesso, pulire oliere, scaricare casse di acqua, nettare cessi. Fino a che, dopo tre o quattro ore di lavoro, arriva la fantomatica clientela. Motore primo di tutto il nostro essere. Si accendono i riflettori, comincia lo spettacolo. Metamorfosi quotidiana da sboccati uomini di fatica a perfetti zerbinotti culostretto. «Buongiorno, buonasera, cosa desidera? senz’altro, a vostra disposizione, un attimo che vado a chiedere in cucina, vi porto subito una bottiglia d’acqua, mi scuso per il ritardo, arrivo subito col seggiolone, un attimo e sono da voi». Non c’è niente di più orripilante di questa farsa. È un mestiere da ipocriti, da schiavi. Non a caso nell’antica grecia gli attori erano schiavi, mica uomini liberi. Perché è una roba che ti scava dentro, che ti cambia fisionomia interiore, finchè non sai bene nemmeno più chi sei. Ve lo garantisco. Menti anche davanti allo specchio, faccia da coglione che hai messo su.
E lo ripeto: l’alcool è il male minore, il pharmacon, il male e la cura al tempo stesso. Non sai più chi sei, e questo è molto peggio di un po’ di cirrosi.
Chi cazzo sei? Un manovale, un lavacessi, un leccaculo, un dipendente sfruttato? Il cliente ha sempre ragione. Il padrone ha sempre ragione, ci mancherebbe. Ti ritrovi tra l’incudine del servilismo e il martello della sevizia patriarcale: quando il cliente avanza certe pretese e il titolare sostiene – come sempre sostiene – che la gente non capisce un cazzo (includendo ovviamente anche tu all’interno di quel sostantivo generalista e collettivo) ecco che ti ritrovi nella merda fino al collo. Lavata di capo assicurata, non ci scappi. Almeno tre o quattro a settimana, se non di più. Umiliazione dal latino umilior, rendere piccolo. O qualcosa di simile. Potessi rispondergli io per le rime, altrochè.
Sopporti, resisti, pazienti. Poi a fine servizio ti attacchi alla bottiglia. O meglio ai fondi delle bottiglie, perché una bottiglia integra, tutta per te, quello è un sogno. Quello non è lavoro, è vacanza. Viviamo di rimanenze. Il fondo delle bottiglie, il fondo delle cicche di sigarette anche. Il fondo della notte. Quante volte mi è capitato, ormai avanti con la sbronza, di pescare dai posacenere avanzi di sigarette spente a metà. Tutta roba sprecata: il vino, il fumo, la vita. La nostra. La nostra, di vita, che se ne va in fumo. Almeno che non vada in aceto.
Mentre gli altri si divertono, mentre gli altri se la spassano e spendono i loro bei soldi guadagnati in gran parte con lavori meno umilianti del nostro. Meno da schiavi.
A chi diavolo gliene frega se lo schiavo è alcolizzato, sniffa colla come i bambini brasiliani, mangia dal trogolo altrui? Lo schiavo l’unico momento di soddisfazione che ha è obnubilamento. Vi piace questa parolona? Obnubilamento. Vuol dire vivere nelle nebbie. Nei fumi dell’alcool. Magari anche di una bella sauna finlandese con una biondona a fianco. Comunque in ogni caso vuol dire un mondo che non esiste ne mai esisterà.
E il bello è che lo schiavo si obnubila e continua a lavorare. Non è che dovete immaginarvelo che si obnubila e sogna disteso in un campo i suoi paradisi artificiali di fuga o rivalsa. Quello magari dopo, molto più tardi, nel cuore della notte. Perché invece da quando i primi clienti se ne vanno, lasciando qualche bottiglia mezzo vuota a cui lui si può attaccare come alla mammella di una madre bastarda ma in fin dei conti anche generosa, devono passare ancora almeno due o tre ore.
Ore in cui lui continuerà lentamente ad ubricarsi, gradualmente (con sapienza professionale, bisogna riconoscerglielo), perpetuando il proprio servizio in maniera quasi ineccepibile. «Buongiorno, buonasera, cosa desidera? senz’altro, a vostra disposizione, un attimo che vado a chiedere in cucina, vi porto subito una bottiglia d’acqua, mi scuso per il ritardo, arrivo subito col seggiolone, un attimo e sono da voi». Sempre lo stesso refrain, solo un po’ più impastato. Un disco rotto. Una volta che lo metti su va avanti quasi col pilota automatico. Qualche guizzo ogni tanto, soprattutto dopo il secondo bicchiere, e allora si vola con un filo di gas. La lingua più sciolta, il passo più dinoccolato – quasi danzante, il sorriso più falso e smaliante, l’occhio che cade più lubrico nelle scollature o che scivola bavoso sulle gambe nude delle signore, delle ragazze, financo delle minorenni, che importa? non facciamo altro che guardare. Non è reato. Guardare e servire, servire e guardare, parlare, scherzare, raccontare (un vino, un’aneddoto, un piatto ricercato). E intanto bere quel che si può bere. Cercando di non mischiare troppo, ma è quasi impossibile: se fossimo stati così meticolosi a quest’ora facevamo i ragionieri. E venivamo qua in questo o quel ristorante a farci servire da qualche schiavo merdoso, alcolizzato, perduto tra i diavoli blu della sua vita di fallito.
Cammina, cammina, schiavo pedestre, ramingo, peregrino. Vedete? Avrei potuto avere un futuro da poeta, ma la vita mi ha portato qui. A quindici anni, finita la scuola dell’obbligo, mio padre mi ha dato un calcio in culo e mi ha condotto da un suo amico, che aveva un albergo al mare: «Adesso imparerai da dove viene il pane» mi ha detto, e mi ha lasciato lì a combattere la mia prima stagione, come il mio primo round. Sette su sette, che nel linguaggio del nostro mestiere vuol dire lavorare per un’intera stagione senza avere mai un giorno di riposo. Ti riposerai dopo, quando la gente tornerà a lavorare.
Ormai sono quarant’anni che faccio questo mestiere. Da quel giorno non ho mai smesso di camminare e servire, servire e riordinare, riordinare e spazzare, spazzare e pulire cessi, e di nuovo riprendere a servire, in un cerchio continuo. Ho imparato da dove viene il pane, ma anche da dove viene il vino, e come procurarmelo senza farmi sgamare dal padrone. Sì, perché ogni titolare è taccagno come un verme e non vuole che i suoi dipendenti bevano, e allora alla veneranda età di cinquantacinque anni, di cui quaranta di servizio, io devo ancora bere di nascosto come un ladro. Come uno sbarbato.
E tutto questo fa schifo, ma è la vita che fa schifo. E non mi pento di un solo sorso di vino tracannato da qualunque bottiglia, soprattutto bottiglie importanti, vini champagne metodo classico da centocinquanta testoni a boccia, col cazzo che le riporto al bancone per vederle scolare nel lavabo prima di essere gettate nella raccolta differenziata. Io mi bevo tutto. Non ho niente da perdere. Io sono il bidone, la raccolta indifferenziata, il canale di scolo di queste vite di opulenza che mi passano davanti. Uomini potenti, donne ben vestite, figli viziati. Prima vi rifilo un vino costoso, poi una seconda boccia quando ormai siete intontiti, poi mi sbronzo a vostre spese con i resti delle vostre gozzoviglie da schizzinosi. Anche nel mangiare, dovreste vedere: certuni lasciano nel piatto certi manicaretti, certi pezzi di filetto. Alla faccia della miseria. Io quando vado a bere state pur certi che mi bevo tutto quel che ho pagato. Questi hanno i soldi che gli escono dal culo. La vita in punta di forchetta. Non tutti imparano da dove viene il pane alla stessa maniera, vorrei dire a mio padre, se fosse ancora vivo.
Anche lui faceva il mestiere. Che detto così, se fosse stato una donna avrebbe significato che faceva la puttana, ma poi il corrispettivo per gli uomini alla fin fine è il cameriere, a mio avviso, e dunque va bene. Certo, portare piatti e portarsi qualcuno a letto non è la stessa cosa, ma questo lo scrivo soltanto per buona educazione nei confronti delle signore, perché avete capito bene come la penso della professione. Alla fine il mood psicologico è lo stesso: tu chiedi, io sorrido e fornisco; tu paghi, io ti dico grazie e torni presto a trovarci.
Con mio padre non ho mai lavorato, ma l’ho visto lavorare. Lui non beveva: era preciso, rapido, meticoloso, integerrimo. Faceva il doppio dei tavoli di qualsiasi altro collega, anche di quelli cocainomani, che sono dei fulmini di guerra, almeno finchè durano. Ma era una mosca bianca, il mio vecchio, tutti gli altri camerieri lo pigliavano per il culo in segreto. Ma anche lo rispettavano, così come si rispetta un alieno. Uomo astemio, o santo o assassino, recita il proverbio. Lui andava al lavabo e svuotava i fondi di bottiglie di Amarone, di Chianti, di Altalanga, senza il minimo tentennamento, come se fosse passatino di verdure per infanti. Nessuno l’ha mai visto attaccarsi al collo di una boccia durante il servizio, io non l’ho mai visto bere più di un bicchiere nemmeno a Capodanno. Chissà se da giovane, non si può mai sapere. I più irreprensibili spesso sono stati i più viziosi. O almeno io mi consolo pensandola così.
Lui ha tenuto insieme la sua famiglia, io no.
Lui ha tenuto insieme la sua vita, io nemmeno questo mi sembra di essere riuscito a fare.
Ogni notte mi stendo sul materasso col mondo che gira un po’, come un neonato che guardi dalla sua culla il carillon pensile con le apette plastificate. Solo che al posto delle ali io ci vedo le etichette delle migliori cantine.
Ho perso tutto quello che la vita poteva offrirmi di buono. Me lo sono bevuto come al biliardo si dice «bersi il punto» quando si fa cadere il birillo sbagliato. Moglie? bevuta. Figlio? bevuto. Diverse migliaia di euro tracannati, bevuti, ingollati, sputtanati ai quattro venti in investimenti assurdi, ruote della fortuna col destino, colpi di testa da coglione, giocate al bingo, al lotto, ai cavalli. Vivendo questa vita vieni a contatto con gente di tutti i tipi, parecchi anche di malaffare. Come potrei riprendermi, continuando a fare questo lavoro? L’unico che so fare. Ormai ci sono dentro fino al collo.
Certo, in un mondo perfetto potrei trasformarmi in mio padre. Divenire ineccepibile, meticoloso, rapido, poi come ho detto? integro? no, integerrimo, che mi sa che è la stessa cosa ma al superlativo. Comunque in ogni caso non so fare altro che questo, l’ho già detto. E per questo intendo sorridere alla clientela, turlupinarla, portargli piatti, stappare bottiglie, scolarmene i fondi quando i signori se ne sono andati, pulire i cessi dove hanno pisciato e anche cagato. Non sono mio padre, forse il mio errore alla base di tutto è sempre stato proprio questo volermi paragonare a lui. Io non so essere che me stesso, non so voi.
In vino veritas è una frase talmente banale che non dovrei nemmeno scriverla, ma la tentazione è forte e io posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni. E così ne ho infilate due al prezzo di una, di citazioni banali. Ma si sa che la banalità paga, soprattutto al tavolo della clientela. Le persone non vogliono altro che essere rassicurate, sentirsi all’interno di un mondo che conoscono. Per questo anche nel campo della ristorazione il conformismo impera, come ovunque. Ingredienti ricercatissimi, ma sempre sull’onda di una moda imperante. Essere fuori è il male, si mangia e si beve ciò che dice il mercato. Adesso essere alcolisti, ad esempio, non va più di moda. Per questo io mi ci incaponisco doppiamente. Viviamo in un mondo light che non serve ad altro che fare il gioco di chi vuole nascondere sotto al tappeto la polvere di troppe malefatte.
Capite che con una parlantina così io il cliente me lo rigiro come voglio. In fatto di lingua sciolta do dei punti anche a mio padre, ne sono convinto. Lui era vecchia scuola, più alla maggiordomo inglese, riservatissimo. Adesso quel tipo di cameriere lì non va più di moda, perché c’è un trend anche per il servizio. Adesso bisogna essere più friendly. «Ciao ragazzi, ciao ragazze, cosa vi porto?». Anche quando i ragazzi e le ragazze hanno trent’anni per gamba. Ma quello che intendo dire qui è altro. E cioè voglio dire che se nel vino c’è la verità, quella verità per me è la verità della disperazione. Ecco, questo non è proprio il significato del proverbio, ma diciamo la mia declinazione personale.
Bevo, e finalmente mi calo la maschera di questa finzione sociale, di questo gioco di padroni e schiavi che mi logora l’anima, e non soltanto a me, potete starne certi. Ma a me si vede di più perché io ho la fortuna e la sfiga di avercelo sempre per le mani, il vino, di averlo come oggetto professionale. Come il muratore ha la cazzuola e l’idraulico la chiave inglese, lo dicevo anche all’inizio.
Ma anche loro poi bevono, non crediate: alla fin fine basta aprire il portafoglio e sganciare. Operai, meccanici, camionisti, facchini. Tutta gente con vite di merda che fa lavori di merda e che come una merda cerca di restare a galla come può. Allora io posso dire che ho il culo di bere gratis, a differenza degli altri fratelli nella disperazione, e dunque non mi va neanche male.
Non è da tutti poter coltivare una dipendenza pluridecennale senza sganciare un centesimo. Alla fine poi tanto cretino non sono. Questa sera, sul lavoro, brinderò alla mia.
Scritto da Marcella Ferrara