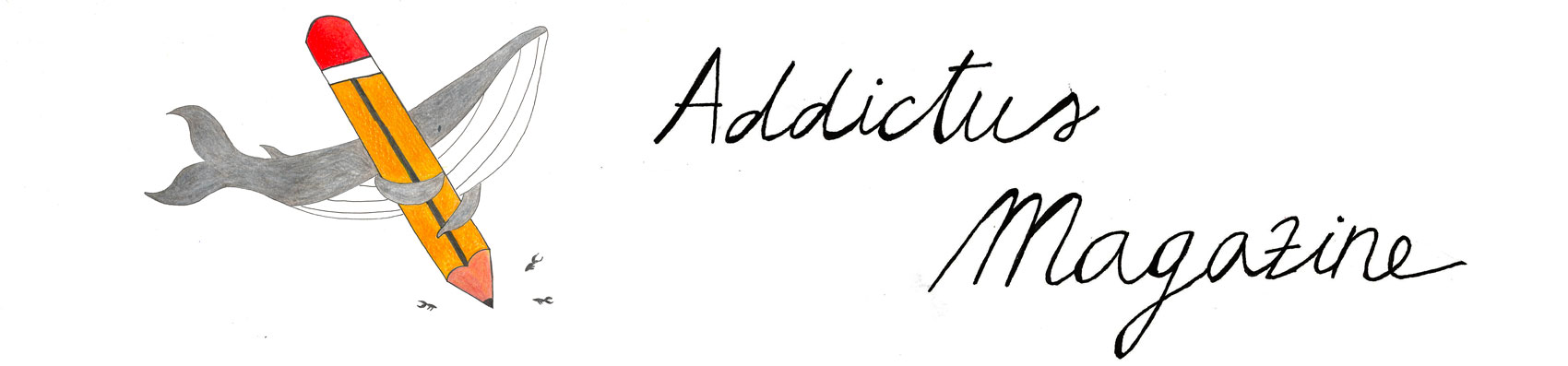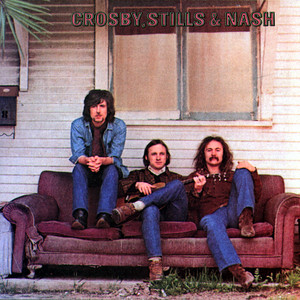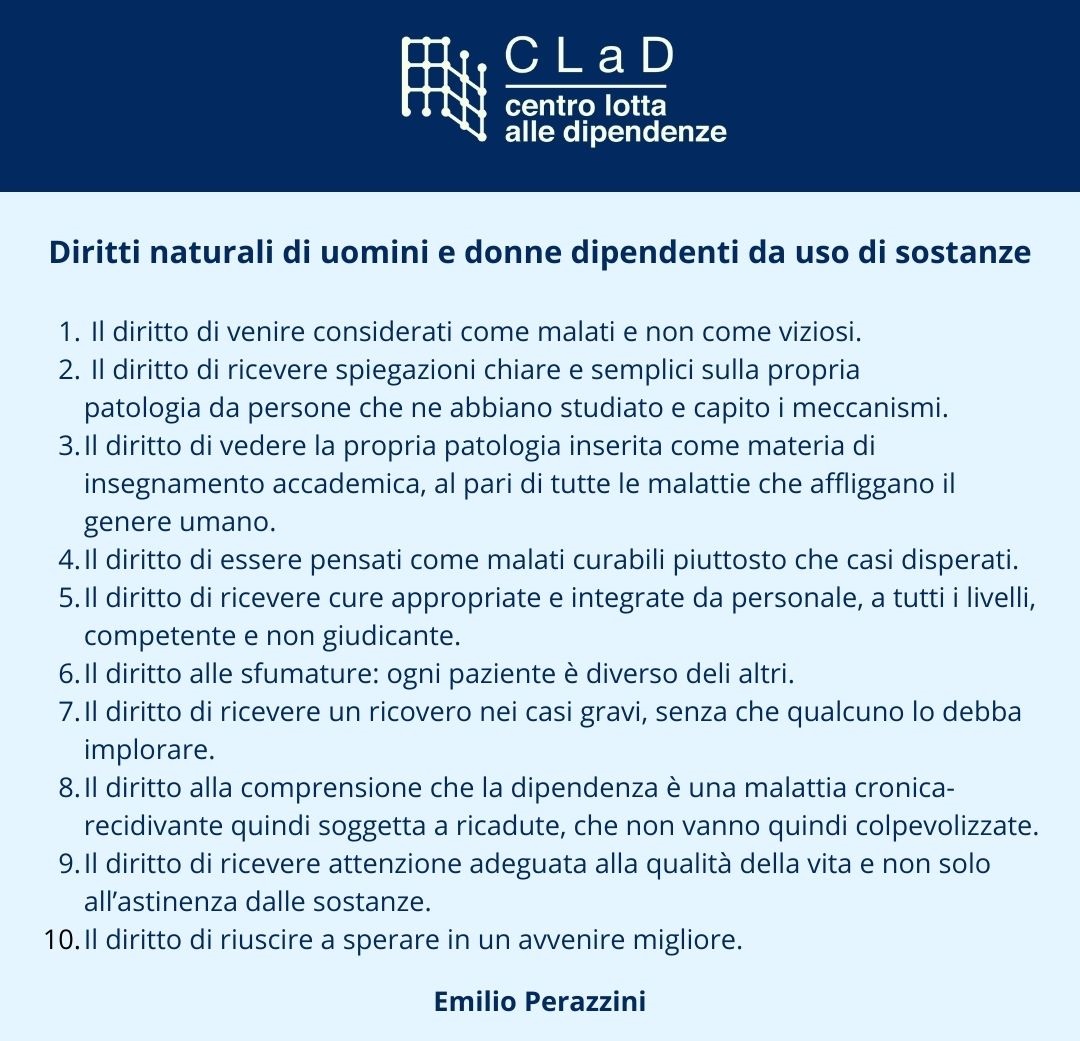Cocaina e scompenso cardiaco
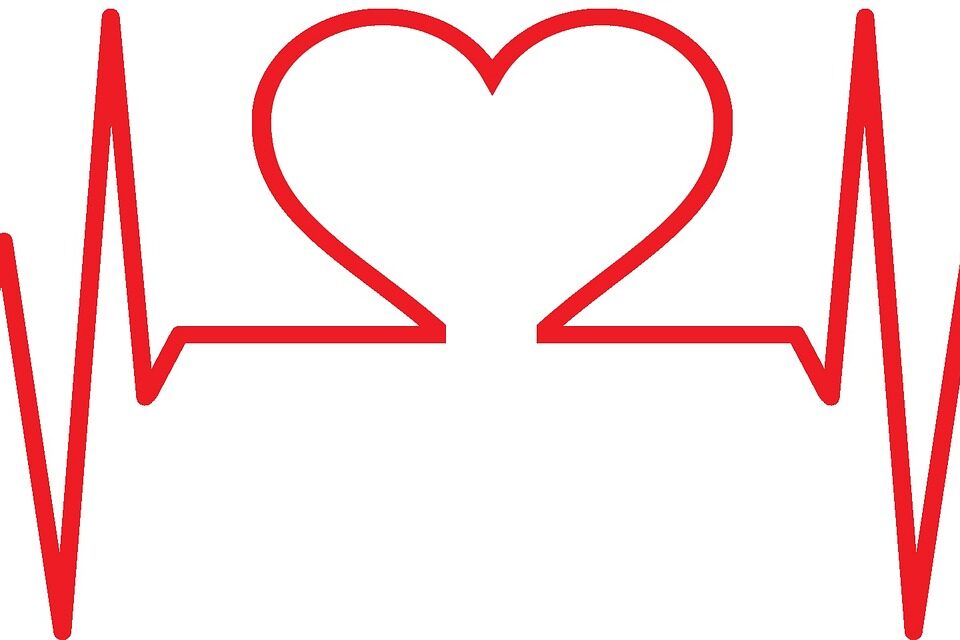
Questa volta ho faticato per trovare un articolo ad accesso libero che potesse interessare i lettori di Addictus Magazine. Tra gli articoli recenti, quelli che mi sembravano più stimolanti erano protetti da paywall; tra quelli liberi stavolta non c’era niente che soddisfacesse i miei gusti di farmacologo pasticcione e medico delle dipendenze a tendenza concreto-pratica.
Alla fine, per questo marzo 2025 mi sono convinto che l’articolo migliore che posso portare alla vostra attenzione è questo:
Alawoè, C., Chapet, N., Roubille, F., Peyrière, H., & Eiden, C. (2024). Narrative review of heart failure related to cocaine consumption and its therapeutic management. Journal of Clinical Medicine, 13(23). https://doi.org/10.3390/jcm13237275
Cosa c’è di meglio di una revisione narrativa sull’insufficienza cardiaca associata al consumo di cocaina, e la gestione della relativa terapia? Uhm. Ok.
Il tema può interessare qualcuno e forse tanti, comunque, quindi vada per questo articolo.
Però, siccome sto in ritardo con l’invio alla redazione, me lo faccio riassumere da chatgpt, e poi prendo il riassunto e lo sistemo in maniera più leggibile e meno meccanica (oramai le cose scritte da chatgpt si riconoscono subito). Ed eccoci qua. Perdonatemi per stavolta (altri argomenti mi spingono molto di più ad addentrarmi e studiare).
Nell’articolo si approfondisce il legame tra uso cronico o acuto di cocaina e lo sviluppo di scompenso cardiaco, ponendo particolare attenzione a diagnosi e terapia.
Gli Autori hanno esaminato la letteratura scientifica pubblicata tra il 2007 e il 2022, selezionando 27 studi tra revisioni, studi clinici, lettere all’editore e case report.
E’ clinicamente rilevante? Indubbiamente. Lo scompenso cardiaco nei consumatori di cocaina presenta un’incidenza nettamente superiore rispetto alla popolazione generale, con una prevalenza variabile tra 2,5% e 20%, contro lo 0,1-0,5% osservato nei giovani non consumatori.
La cocaina – insomma – fa male al cuore, spesso e assai.
Dal punto di vista clinico, l’insufficienza cardiaca correlata all’uso di cocaina può manifestarsi con un fenotipo a ridotta frazione di eiezione (HFrEF) o a frazione di eiezione preservata (HFpEF), associata a ipertrofia ventricolare, disfunzione diastolica e alterazioni del rimodellamento cardiaco.
La patogenesi della disfunzione miocardica si può paragonare agli effetti di una guerra rivolta al cuore con bombardamenti da tutte le parti.
Intanto, per cominciare, a cocaina blocca vari canali transmembrana delle cellule del miocardio, ovvero i canali ionici di calcio di tipo L, i canali del potassio KCNH2 e quelli del sodio voltaggio-dipendenti, inducendo instabilità della trasmissione degli impulsi elettrici che propagano la contrazione, e predisponendo di conseguenza ad aritmie ventricolari, ischemia e disfunzione contrattile.
Se questo non bastasse, l’iperattivazione della branca simpatica del sistema nervoso autonomo promossa dalla cocaina induce danno ossidativo, con eccessiva produzione di radicali liberi dell’ossigeno, reattivi e dannosi per la cellula, e conseguente disfunzione mitocondriale e morte cellulare programmata dei cardiomiociti.
Inoltre la cocaina aumenta i livelli di endotelina-1 (vasocostrittore), riduce l’ossido nitrico (vasodilatatore) e aumenta l’aggregazione piastrinica (ostruttiva), un terzetto micidiale per la perfusione dei tessuti e anche del cuore, favorendo vasospasmo coronarico, trombosi e accelerazione dell’aterosclerosi.
Ma non basta, aggiungiamo ai cavalieri dell’Apocalisse anche l’infiammazione, che porta nel tempo a fibrosi interstiziale miocardica, con conseguente rigidità ventricolare, ridotta compliance e sviluppo di insufficienza cardiaca diastolica: il cuore non si distende, non accoglie il sangue, e quindi ne pompa meno del dovuto.
Che fare? Terapia: beta-bloccanti e smettere.
Ora, è noto da anni che i beta-bloccanti presi insieme alla cocaina possono avere effetti opposti a quelli che uno si aspetterebbe, e anziché abbassare la pressione possono innalzarla in maniera paradossa perché l’adrenalina a quel punto essendo bloccati i recettori beta può agire solo sui recettori alfa, che per l’appunto alzano la pressione. Vedasi per esempio Ramoska, E., & Sacchetti, A. D. (1985). Propranolol-induced hypertension in treatment of cocaine intoxication. Annals of Emergency Medicine, 14(11), 1112–1113. https://doi.org/10.1016/s0196-0644(85)80934-3
Però però… the times they are a-changing (citazione Dylaniana).
Intanto al giorno d’oggi si consiglia di non togliere i beta-bloccanti ai pazienti con problemi di cocaina che li stanno prendendo per i loro problemi cardiologici, e se per caso gli sono stati tolti, si consiglia di rimetterli (Mazumdar, K., Train, M. K., & Readlynn, J. K. (2024). Things We Do for No ReasonTM: Discontinuing β-blockers in patients who use cocaine. Journal of Hospital Medicine: An Official Publication of the Society of Hospital Medicine, 19(6), 524–526. https://doi.org/10.1002/jhm.13245 )
Poi – incidentalmente – il propranololo (il più vecchio dei beta-bloccanti tuttora in uso clinico) è considerato da alcune scuole di medicina delle dipendenze (vedi scuola francese) come un buon farmaco per aiutare a interrompere il consumo della sostanza soprattutto in chi soffre sintomi astinenziali (Kampman KM, Volpicelli JR, Mulvaney F, et al. Effectiveness of propranolol for cocaine dependence treatment may depend on cocaine withdrawal symptom severity. Drug Alcohol Depend. 2001;63(1):69-78. https://doi.org/10.1016/s0376-8716(00)00193-9 )
Ci vuole cautela e raziocinio secondo me.
I beta bloccanti dovrebbero essere usati al di fuori delle condizioni di consumo attivo della cocaina o dell’intossicazione acuta. Opinione non da cardiologo.
Comunque torniamo al sunto dell’articolo.
Secondo gli Autori, le più recenti evidenze suggeriscono che nell’insufficienza cardiaca associata alla cocaina, alcuni beta-bloccanti, in particolare carvedilolo, possono essere utilizzati con un profilo di sicurezza favorevole. Essendo un beta-bloccante non selettivo, il carvedilolo avrebbe un’azione α-bloccante aggiuntiva, che potrebbe attenuare la vasocostrizione indotta da cocaina e migliorare il flusso coronarico.
Il carvedilolo darebbe luogo a un miglioramento della funzione cardiaca, con recupero della frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVEF) e riduzione della sintomatologia congestizia.
Questo sarebbe associato a significativa riduzione della mortalità per tutte le cause e dei tassi di reospedalizzazione per scompenso cardiaco.
Gli Autori concludono in maniera abbastanza lapalissiana che comunque l’elemento determinante per il miglioramento a lungo termine è la cessazione completa dell’uso di cocaina: nei pazienti che interrompono il consumo, si osservano miglioramenti significativi della funzione ventricolare sinistra, con recupero parziale della contrattilità miocardica, che può raggiungere il recupero completo nei casi meno avanzati.
Come si fa? Pian piano stiamo imparando (in realtà siamo forzati ad imparare rapidamente visto che il mercato delle sostanze psicoattive illegali è virato ovunque in Europa, Italia compresa, su cocaina e crack). Ma questa è un’altra storia.